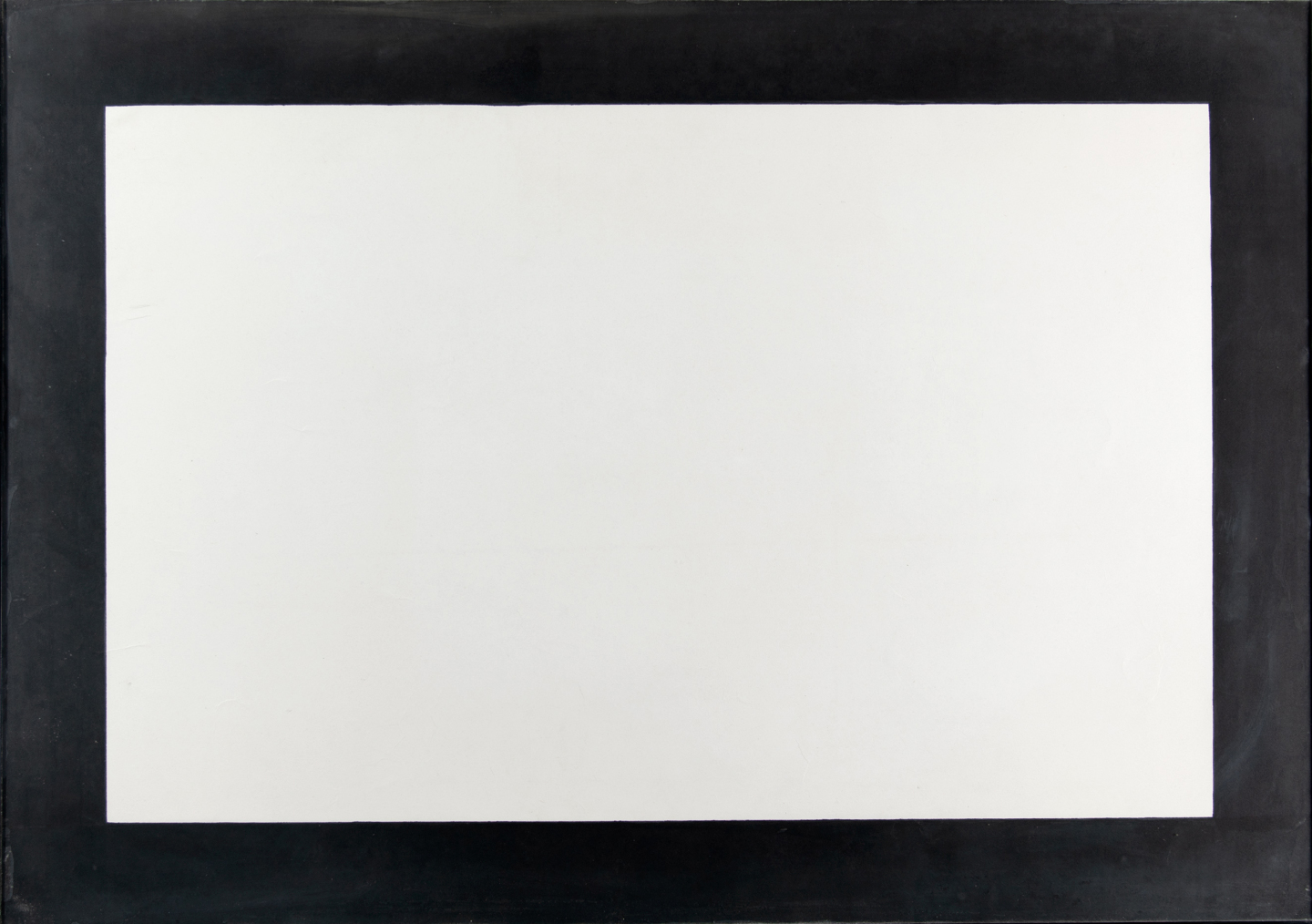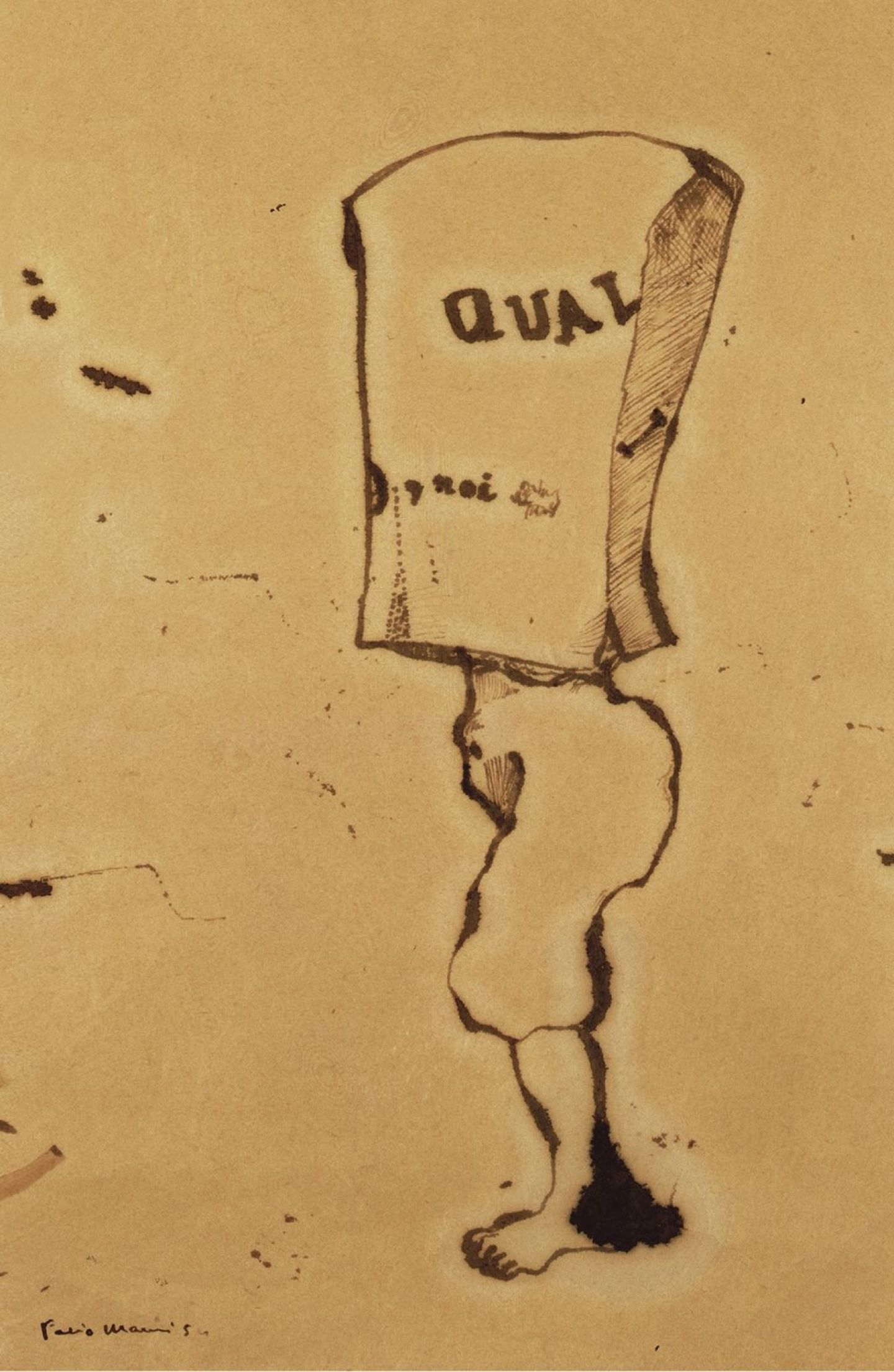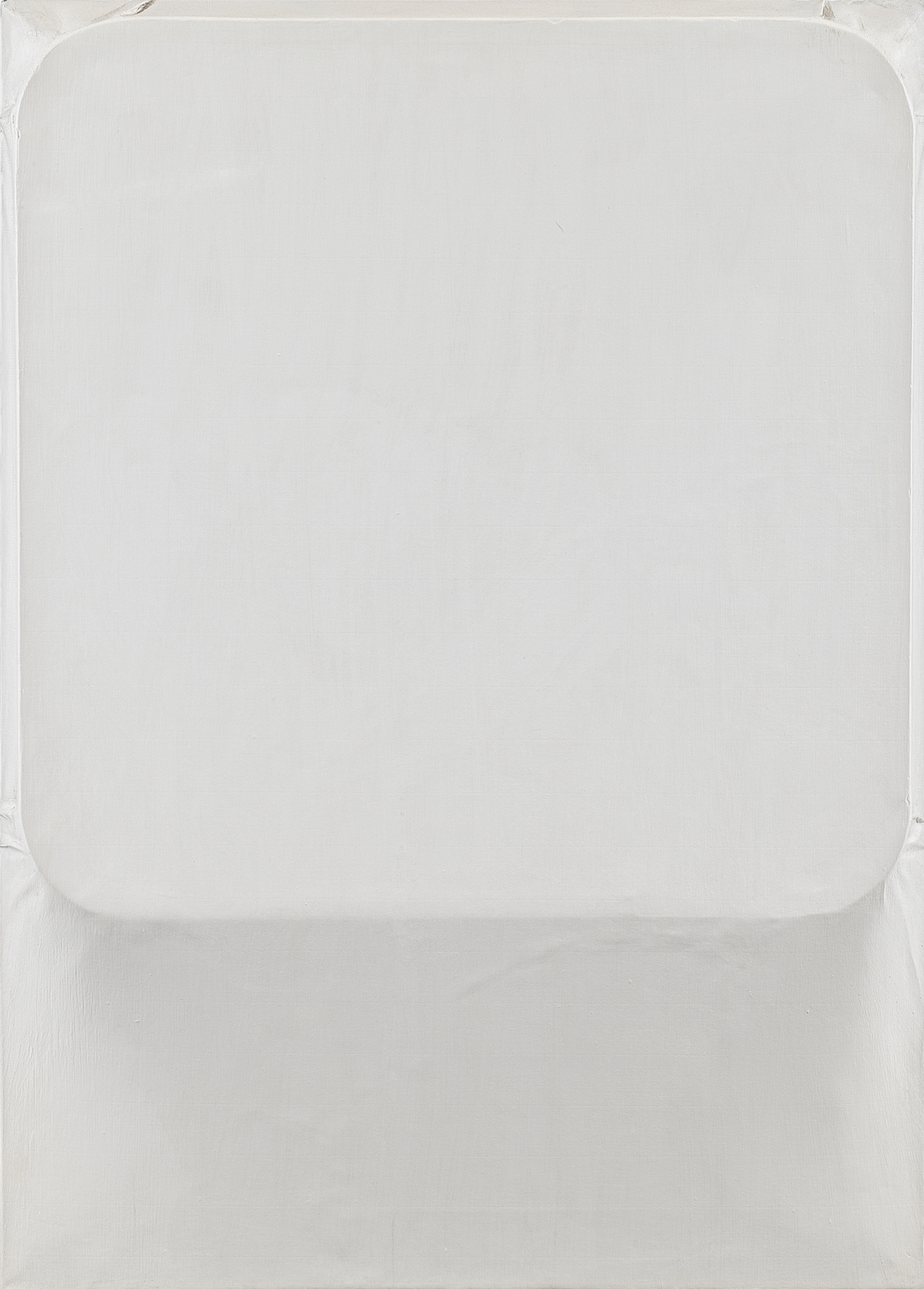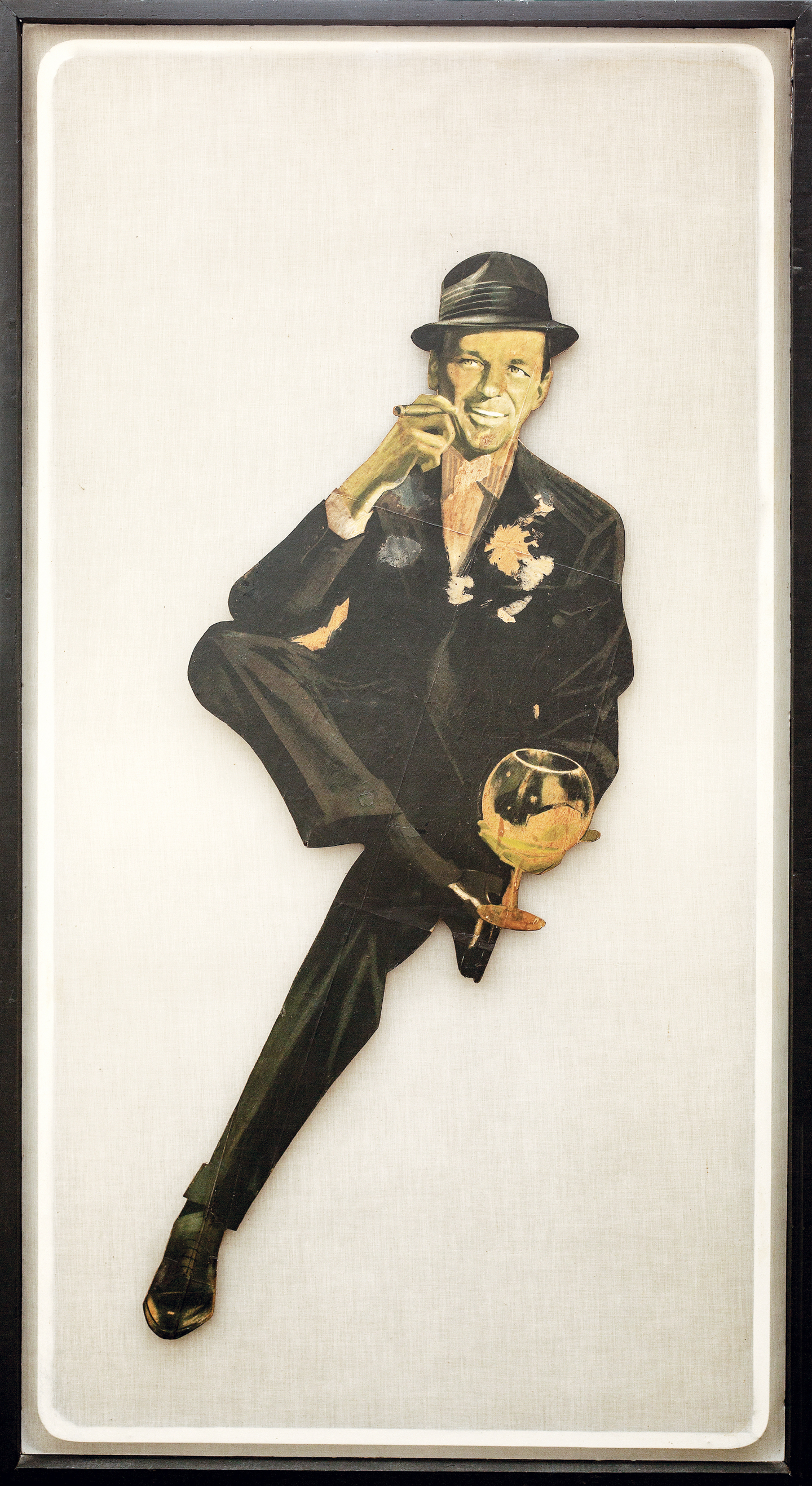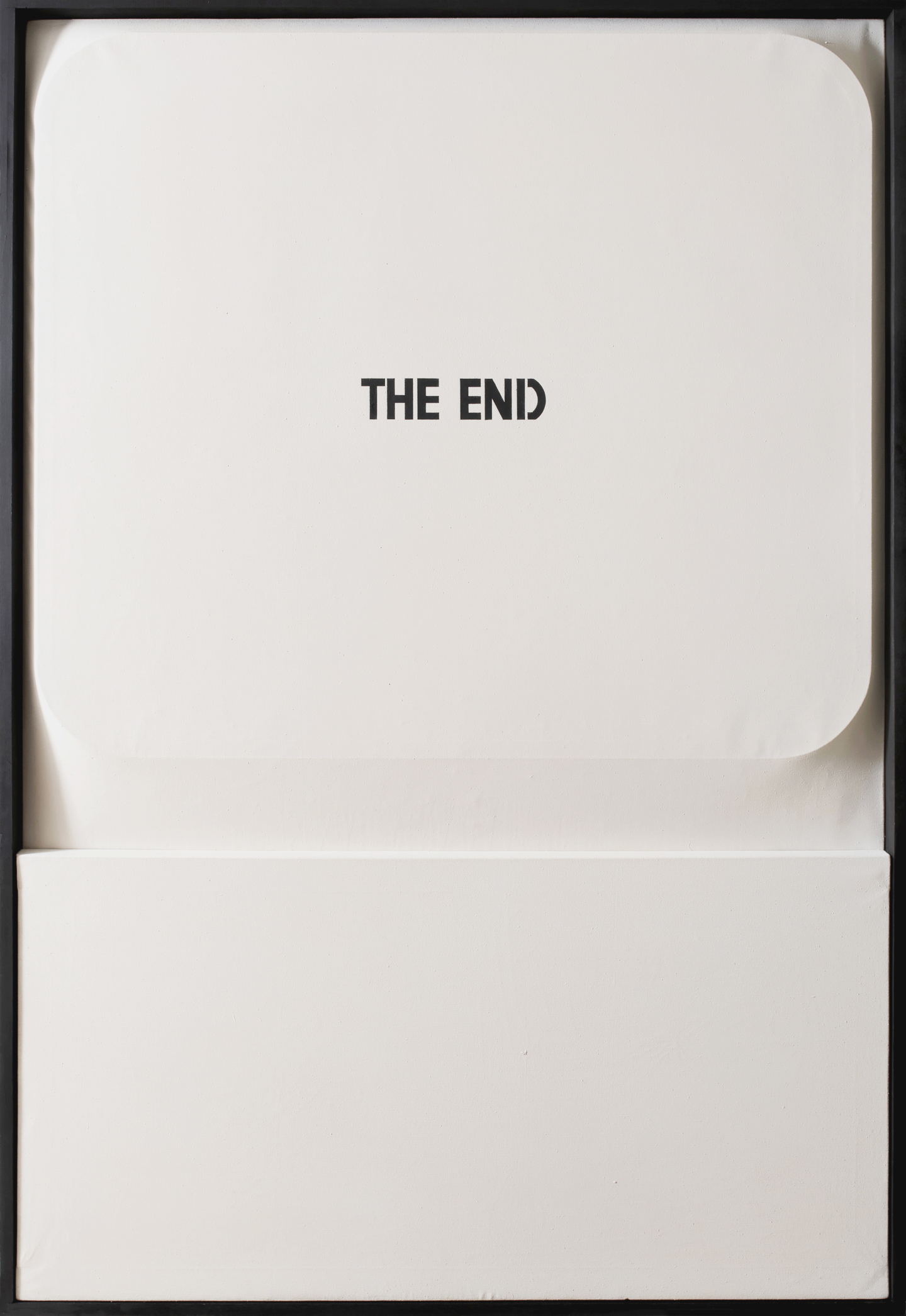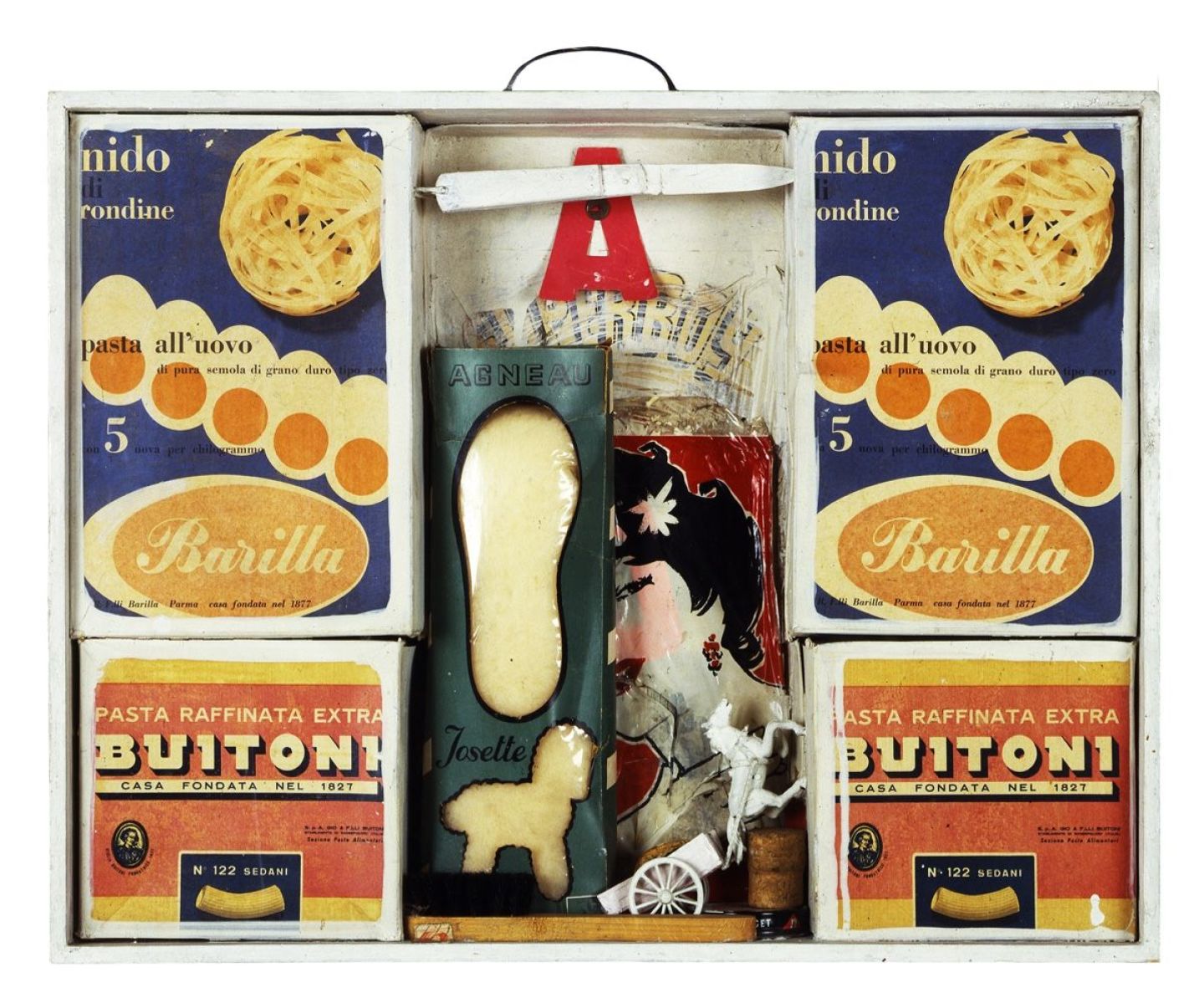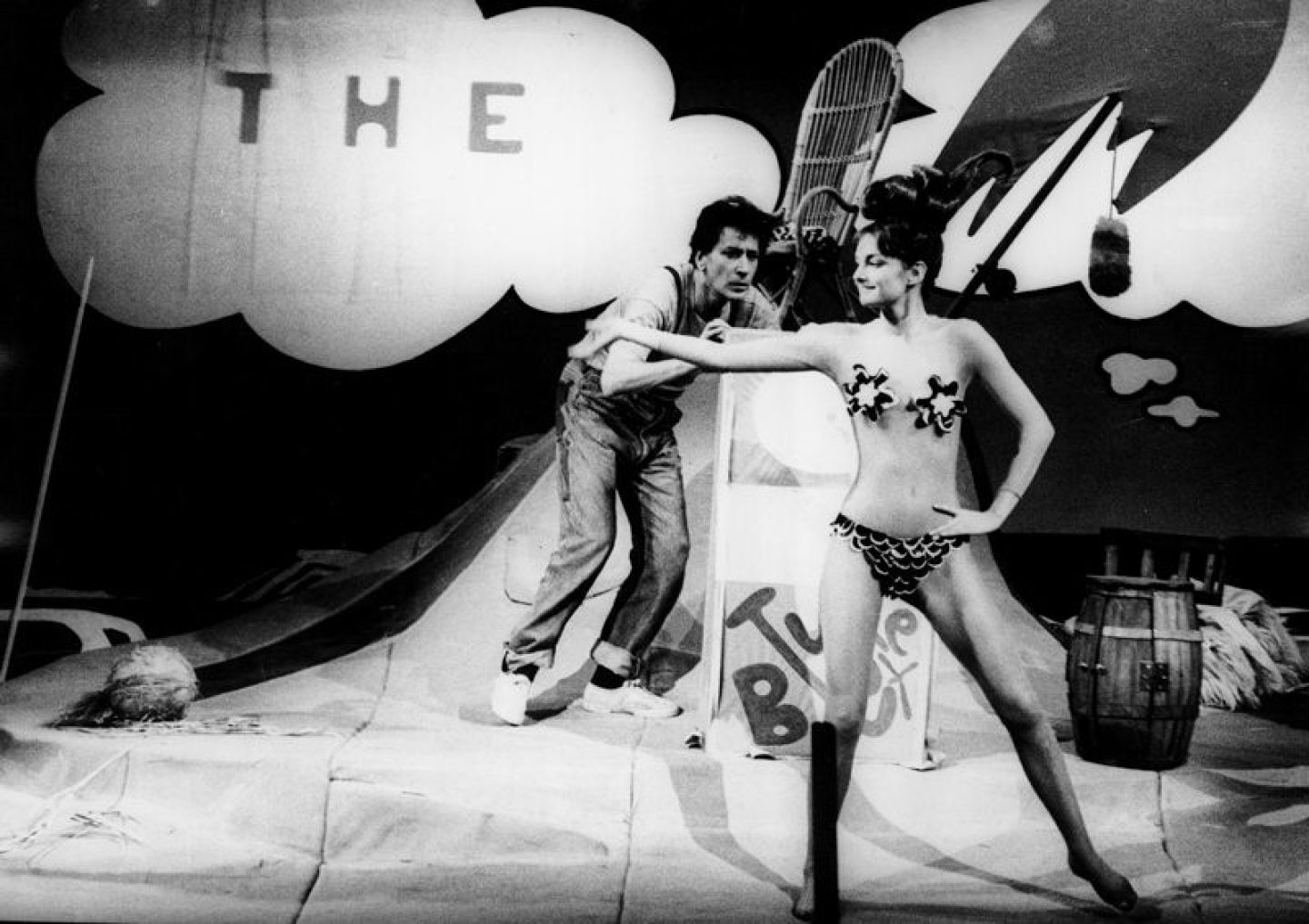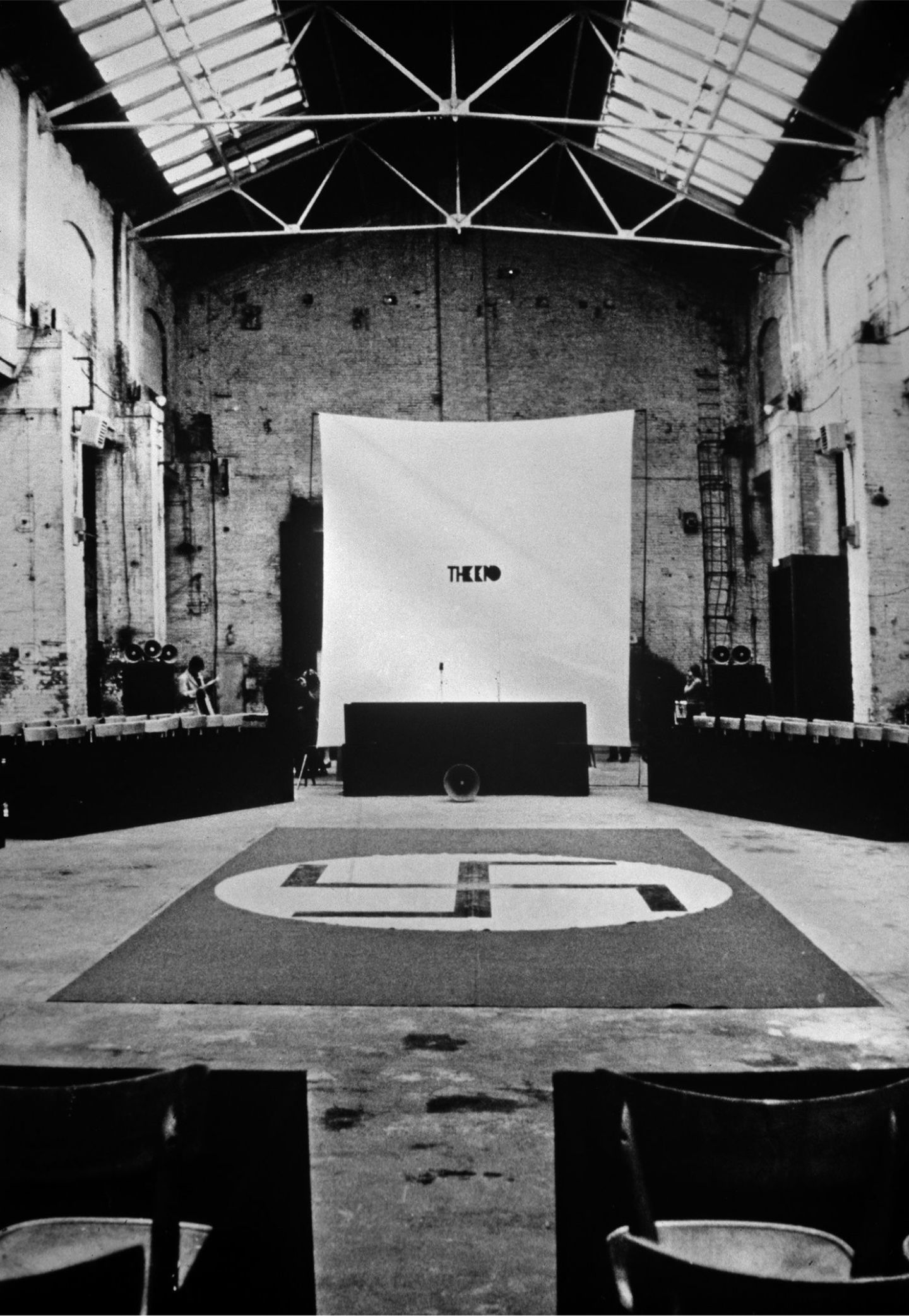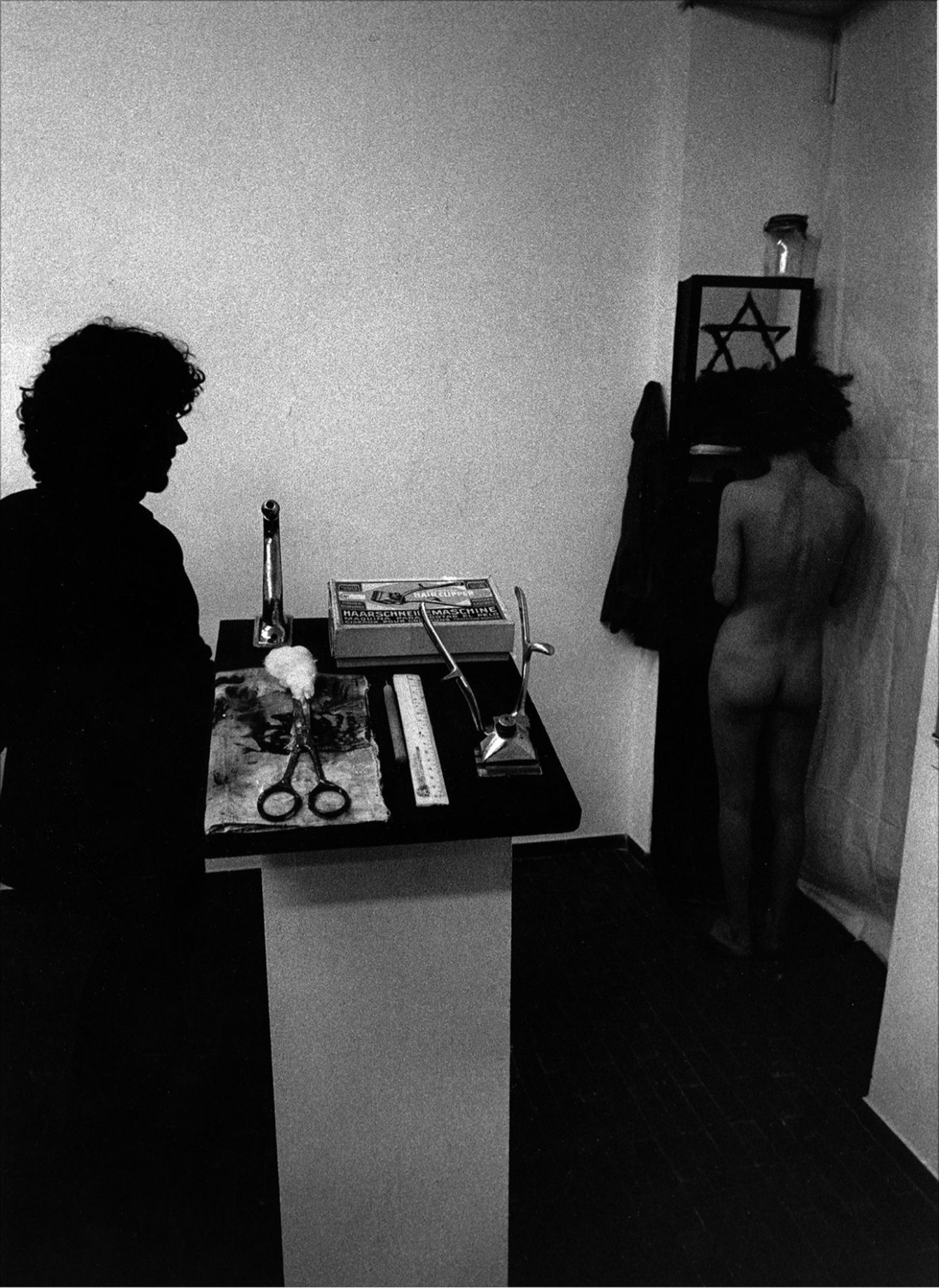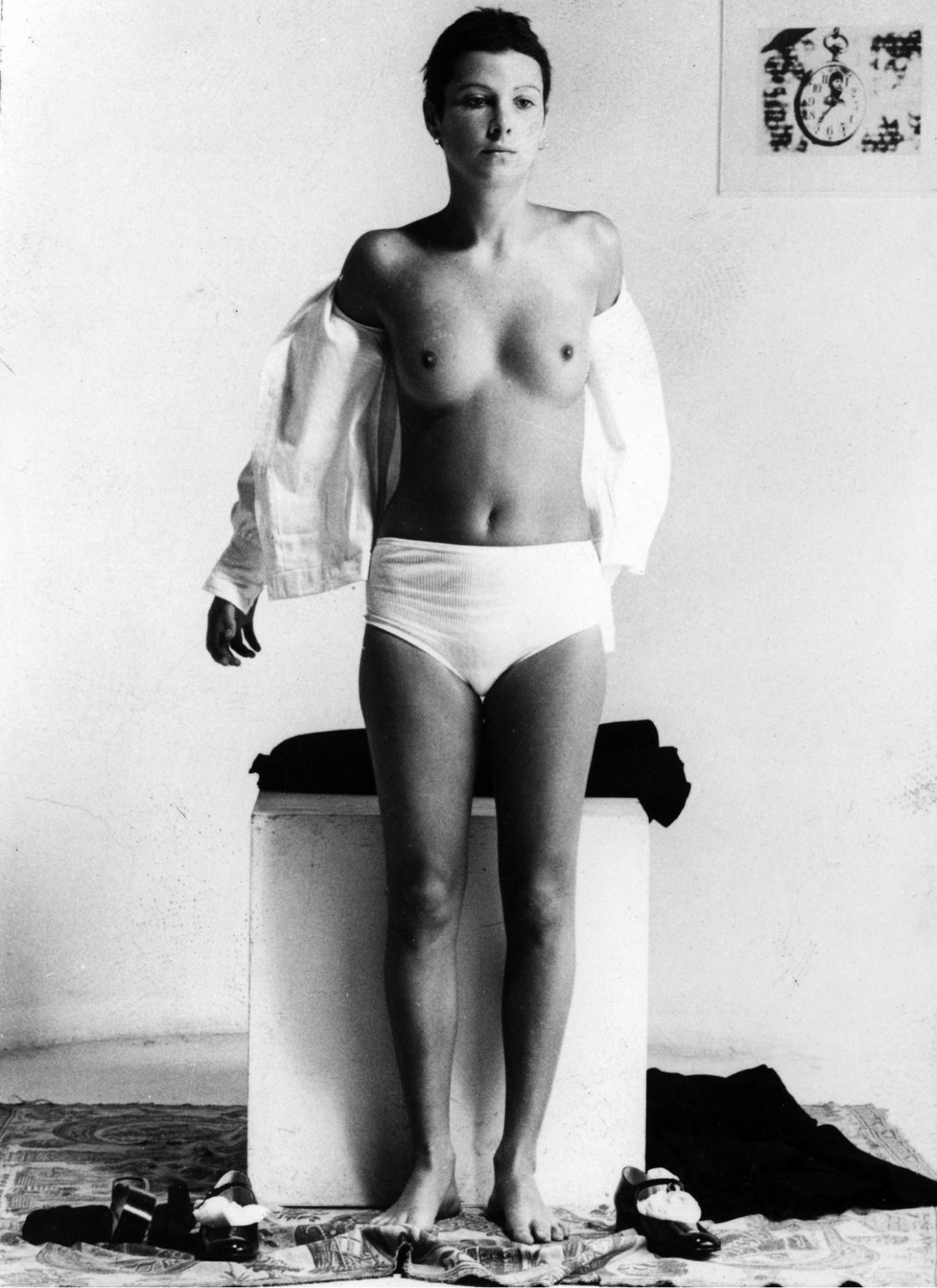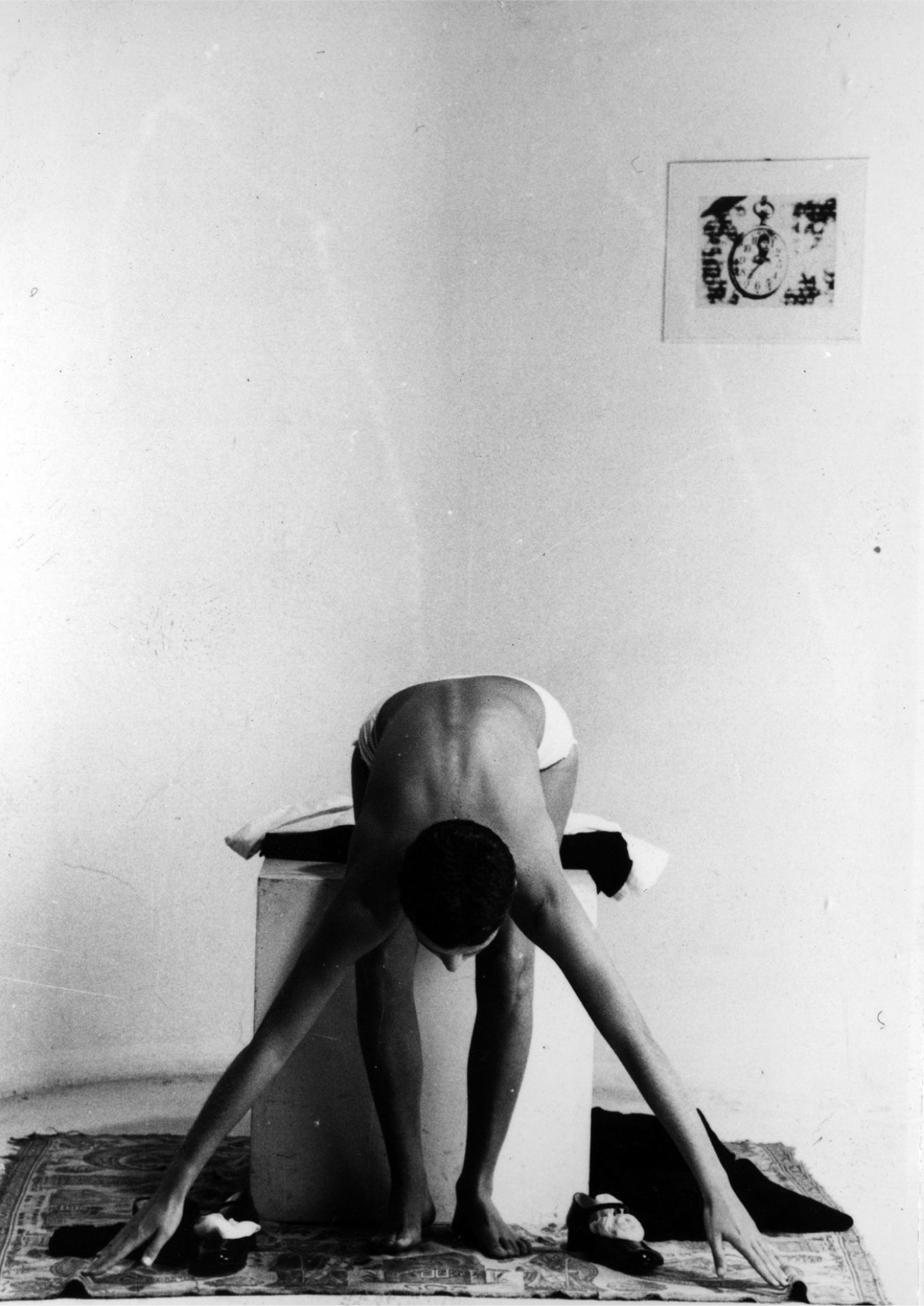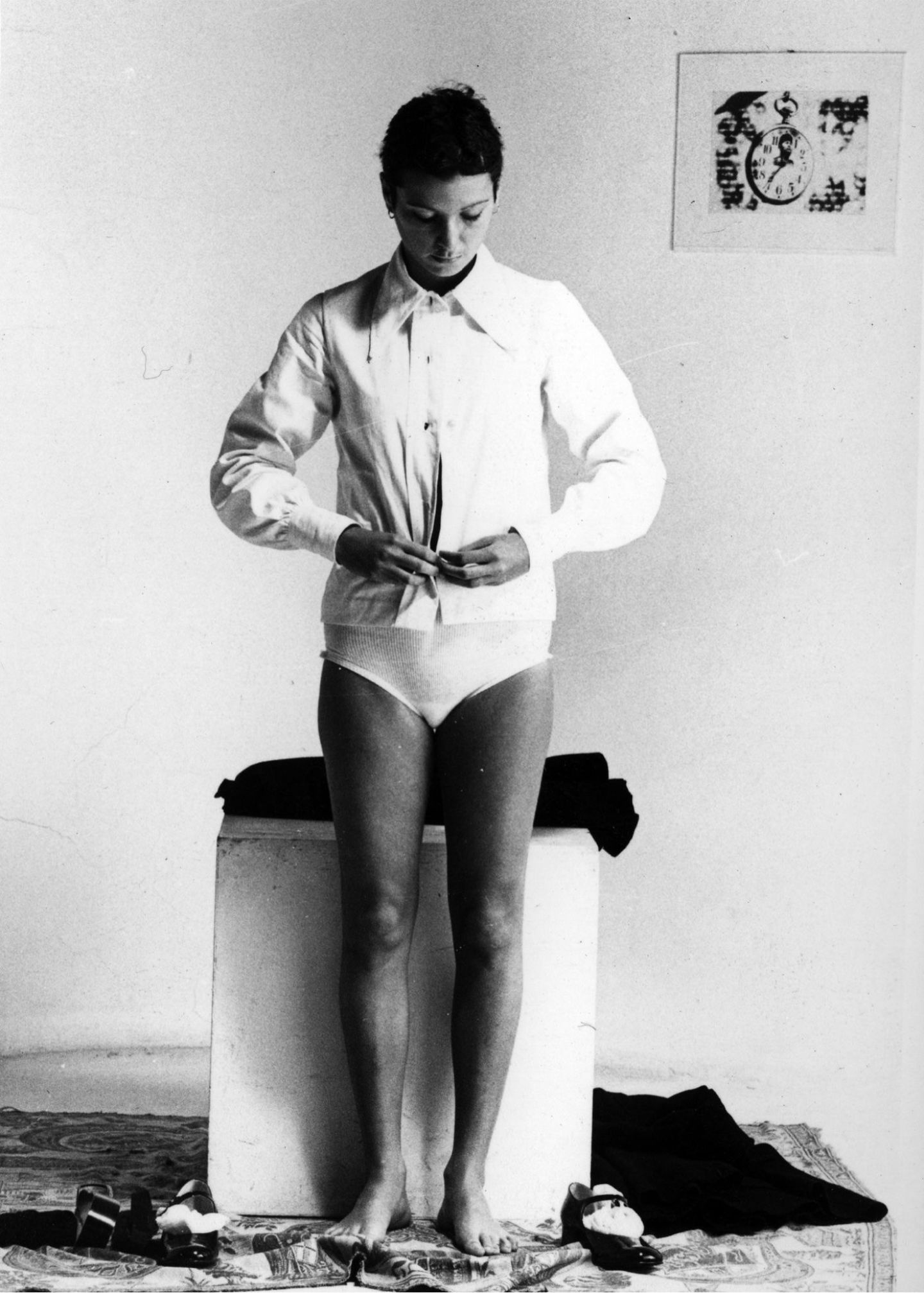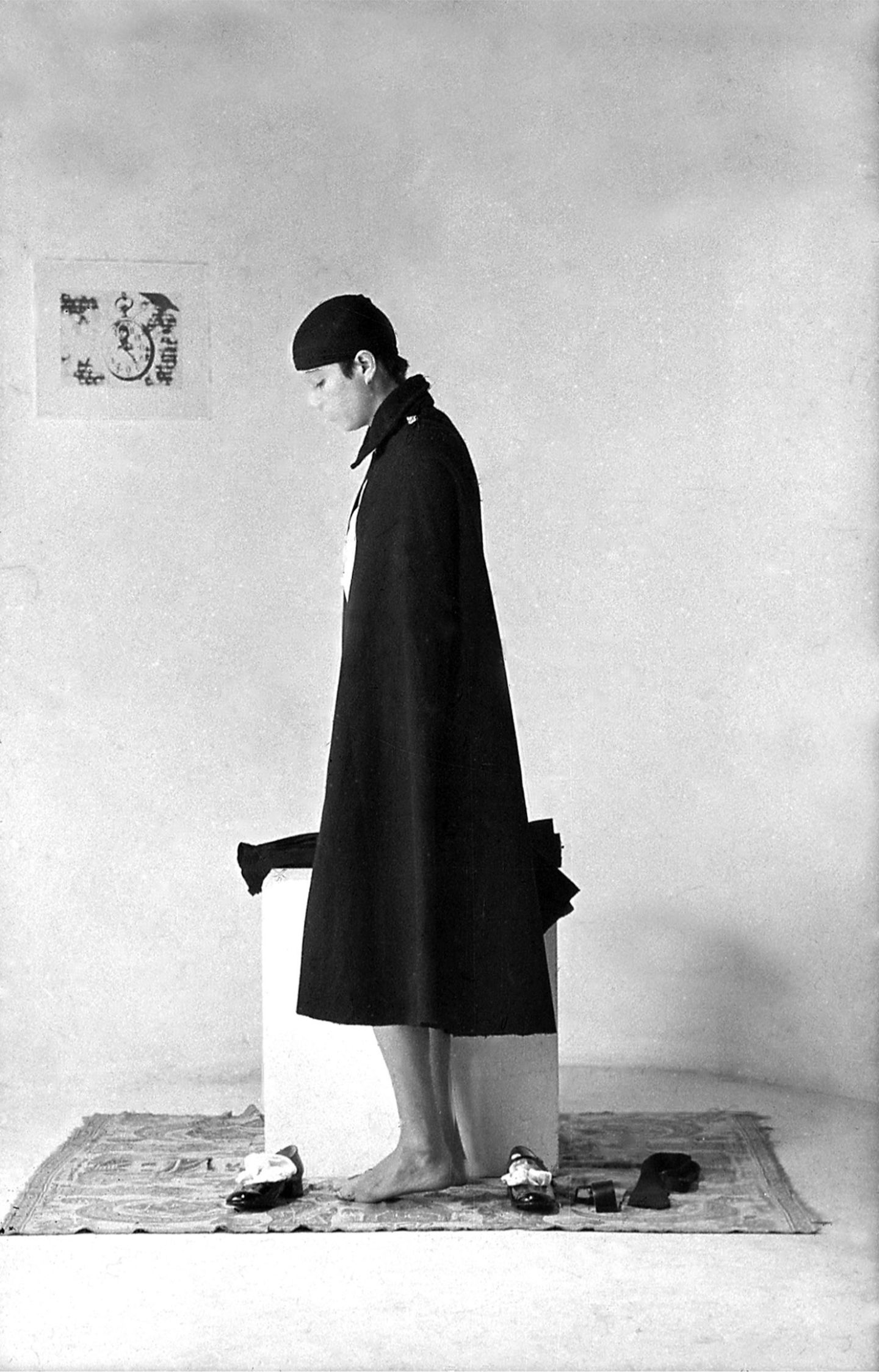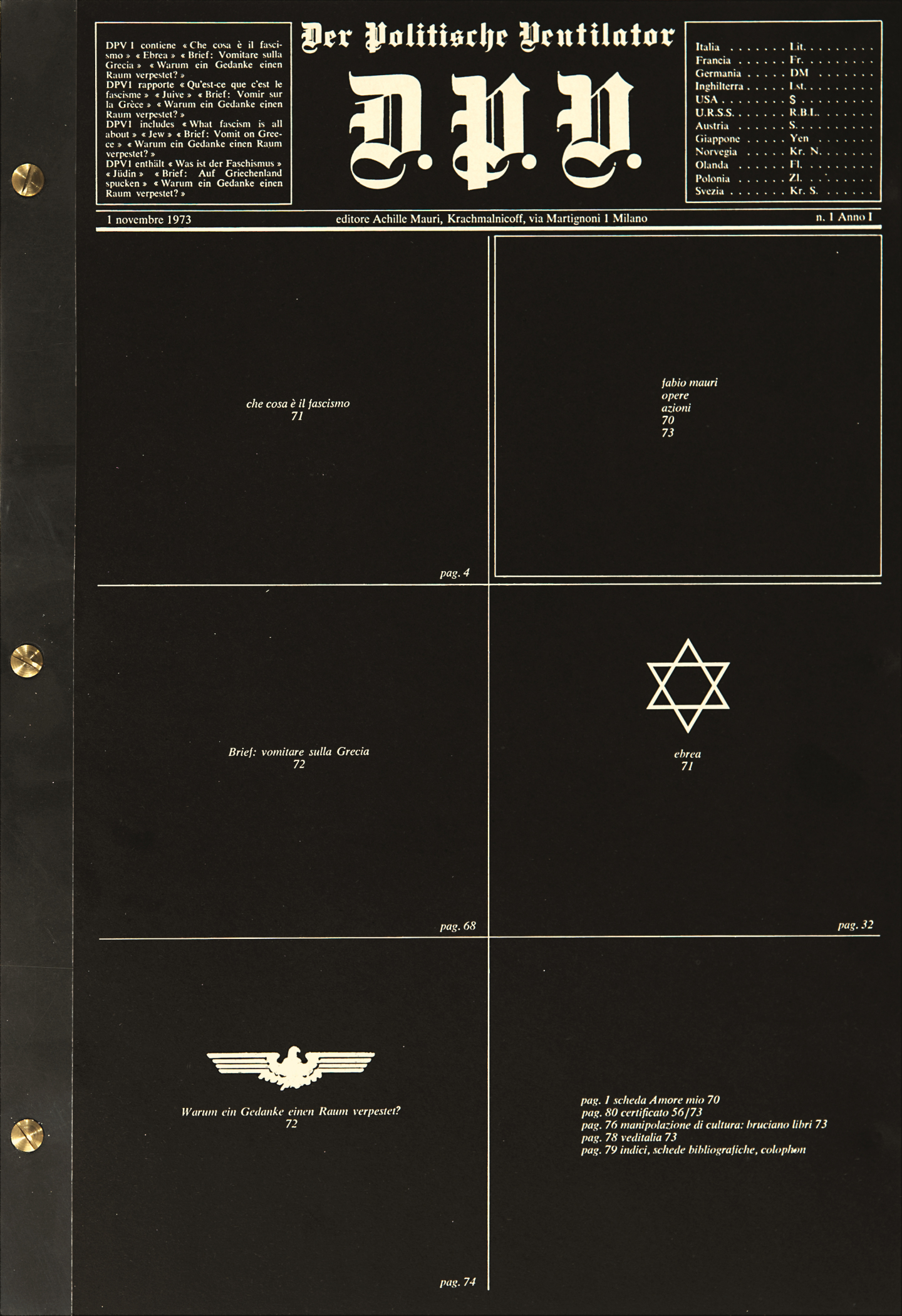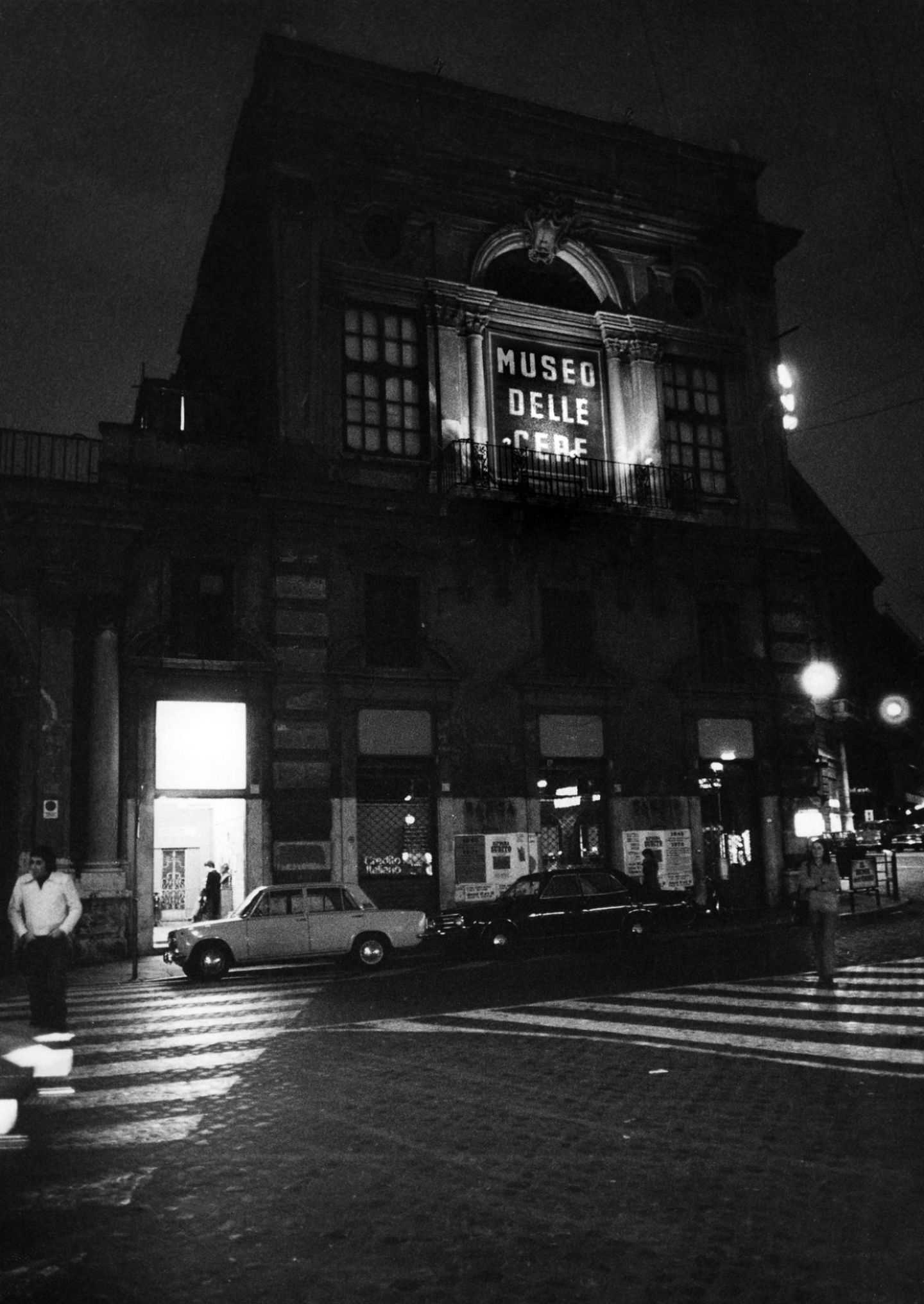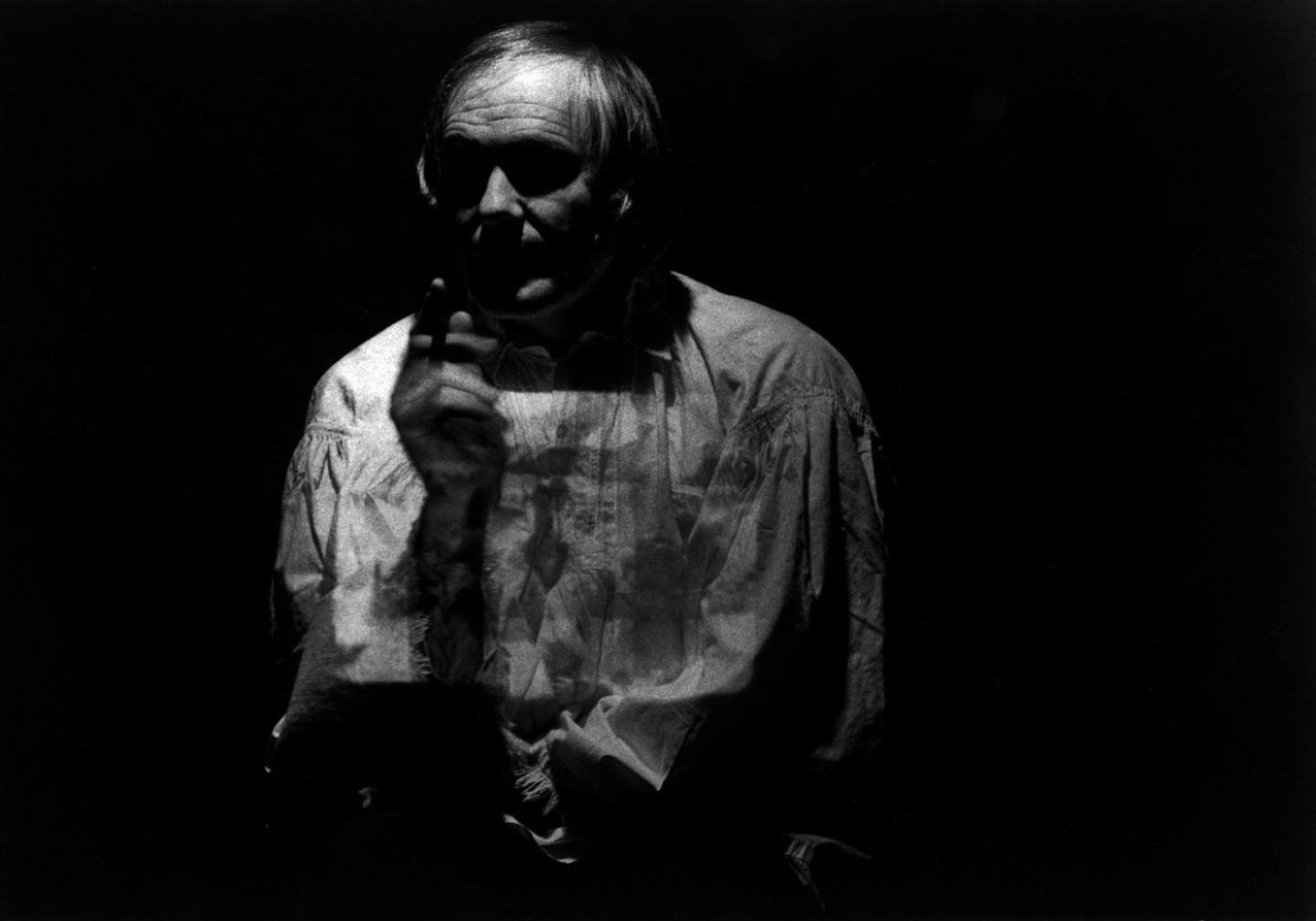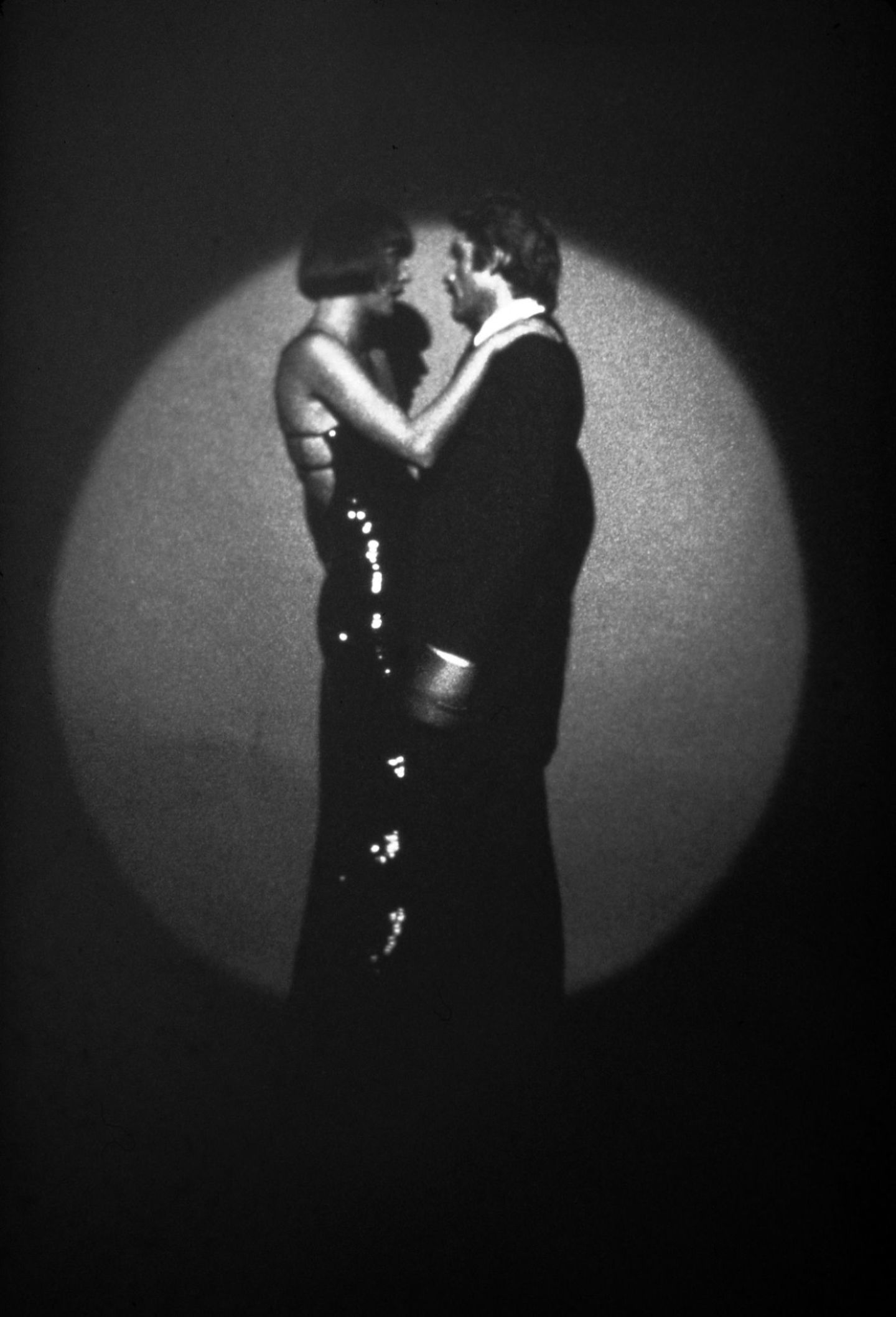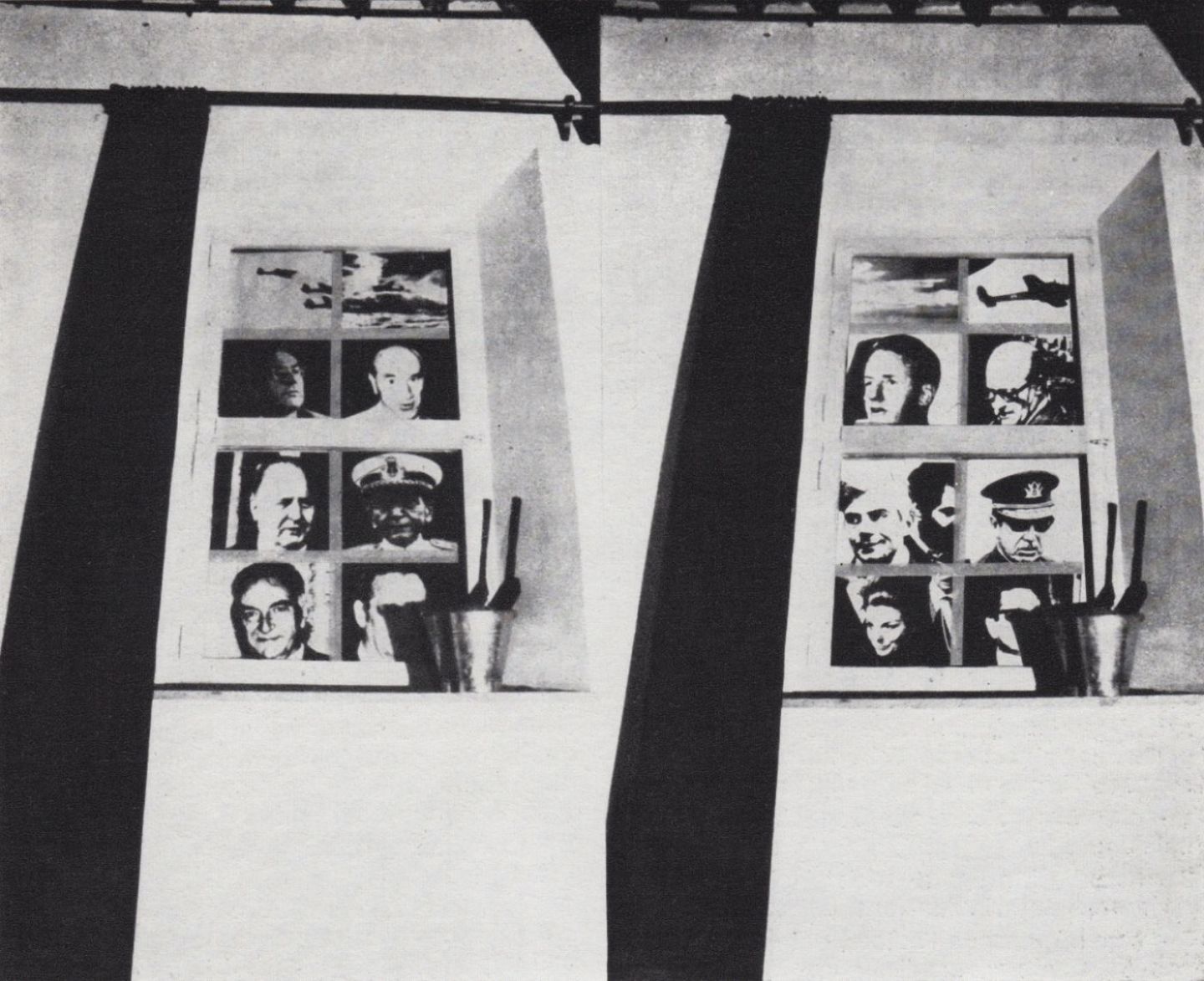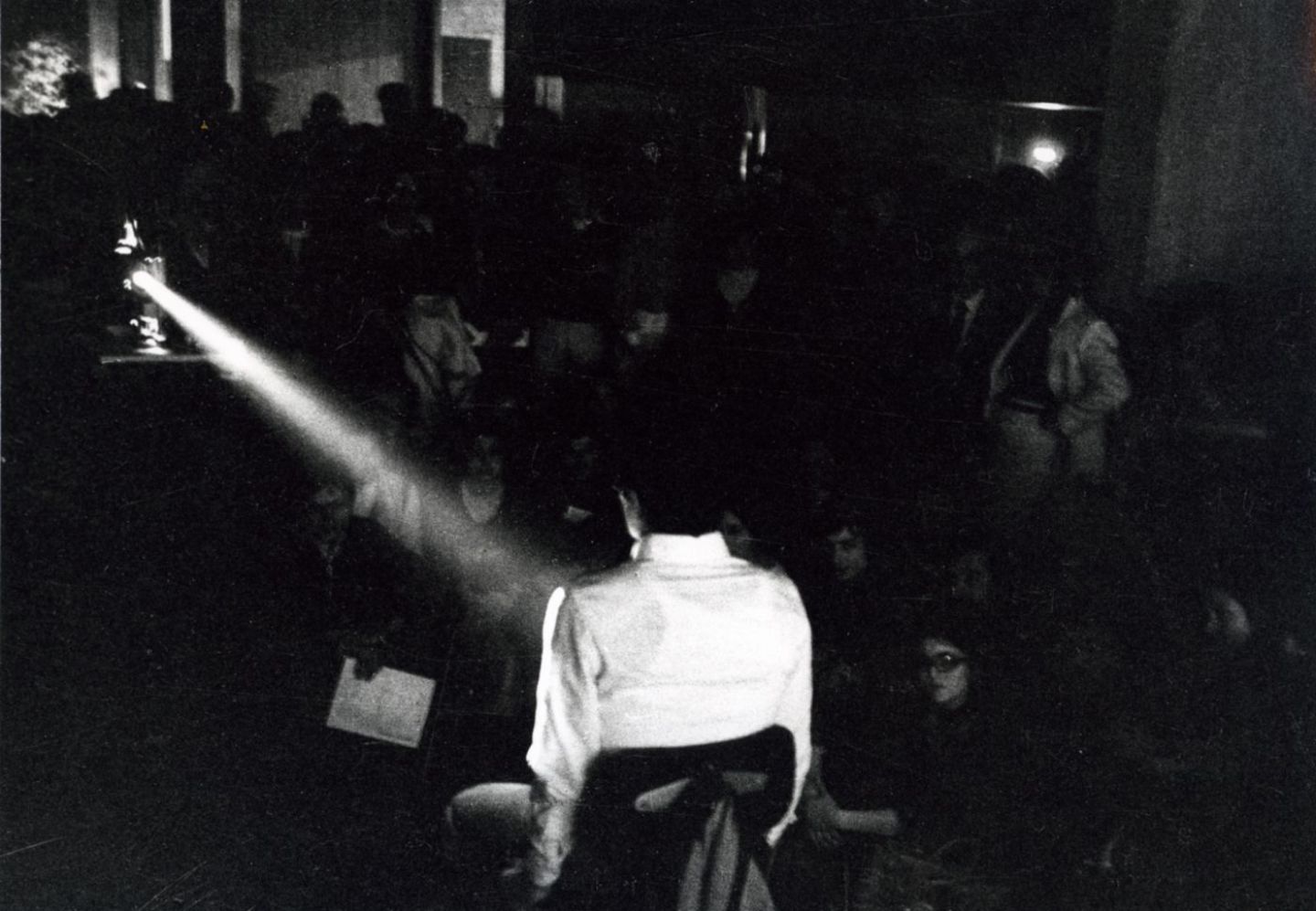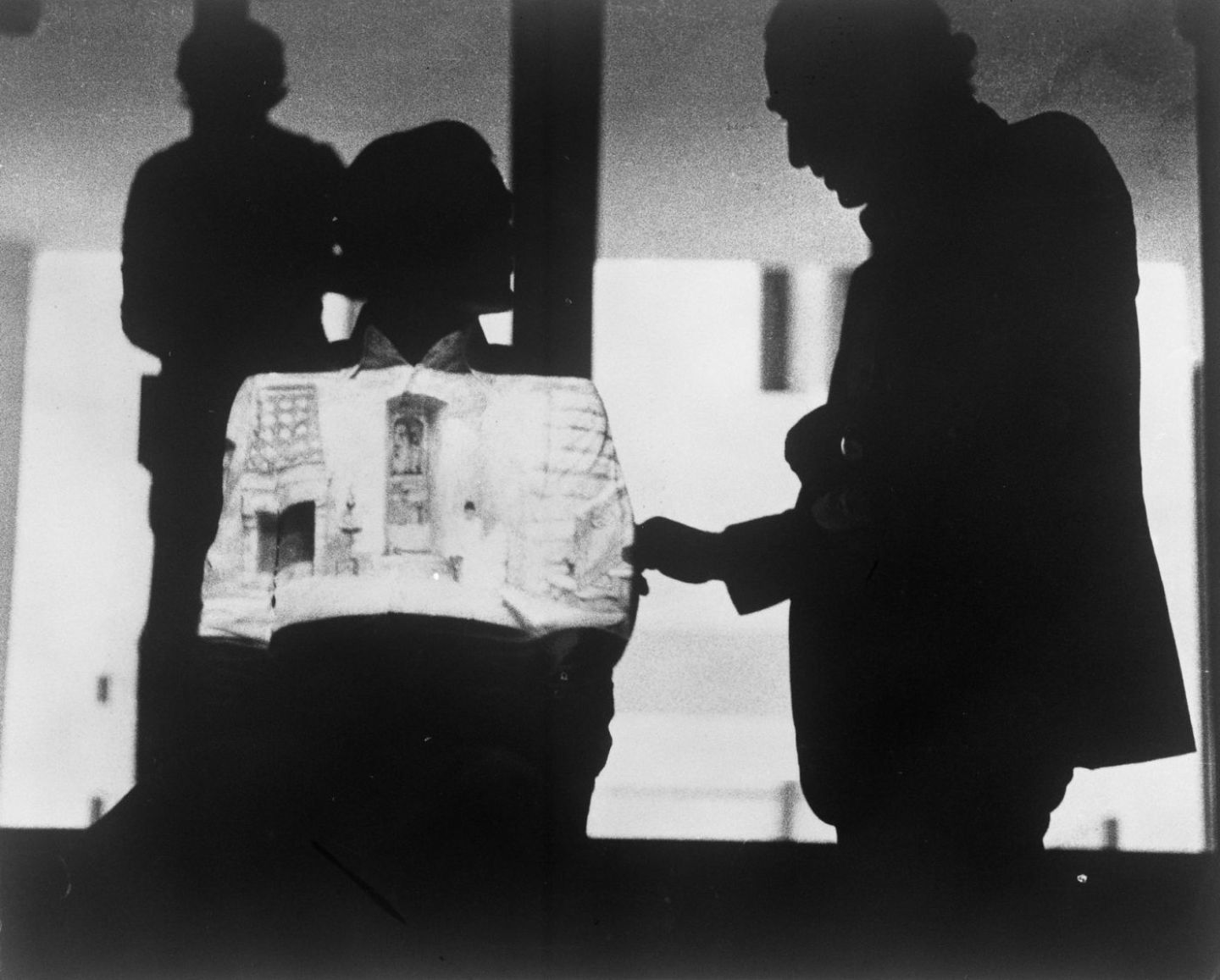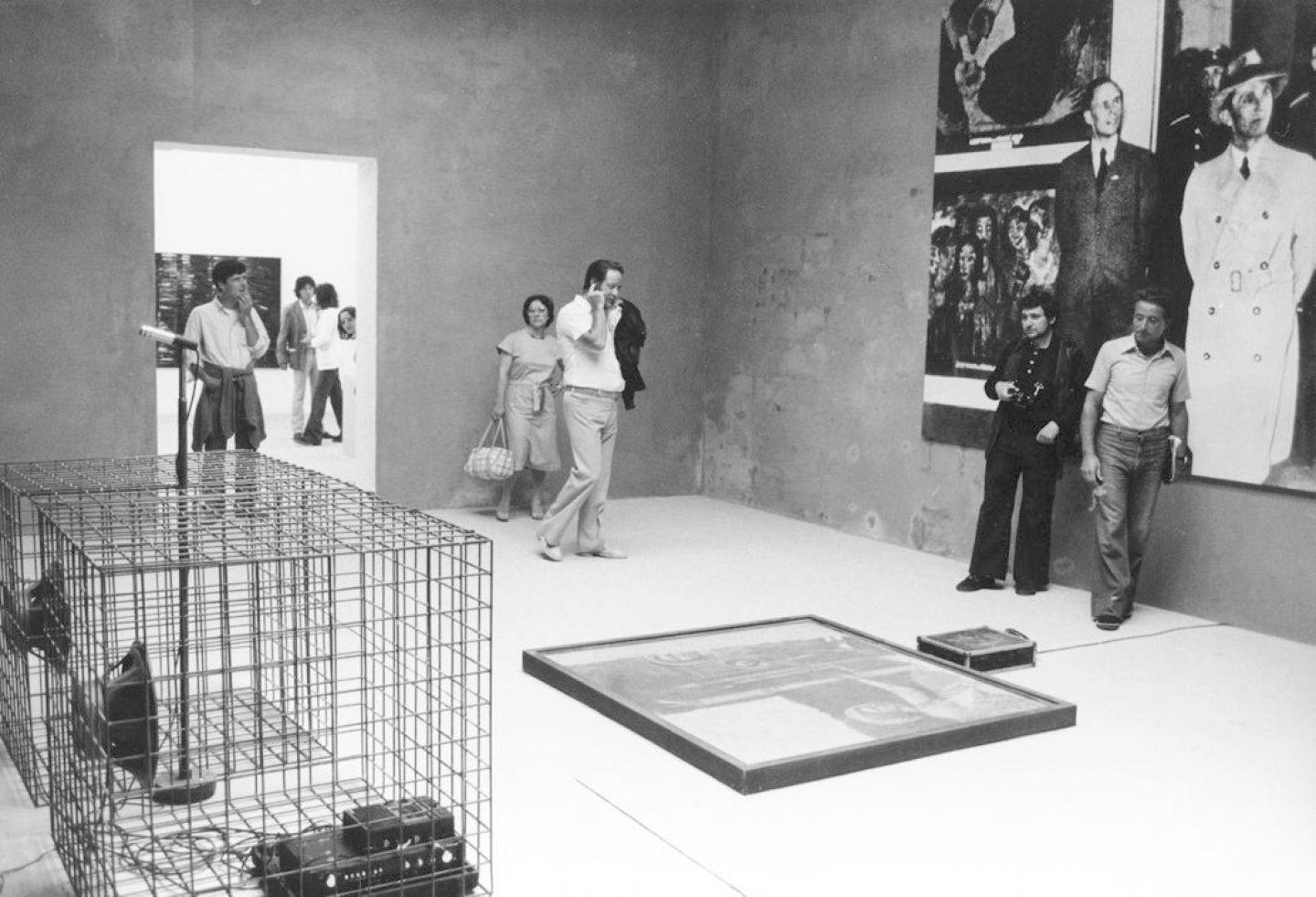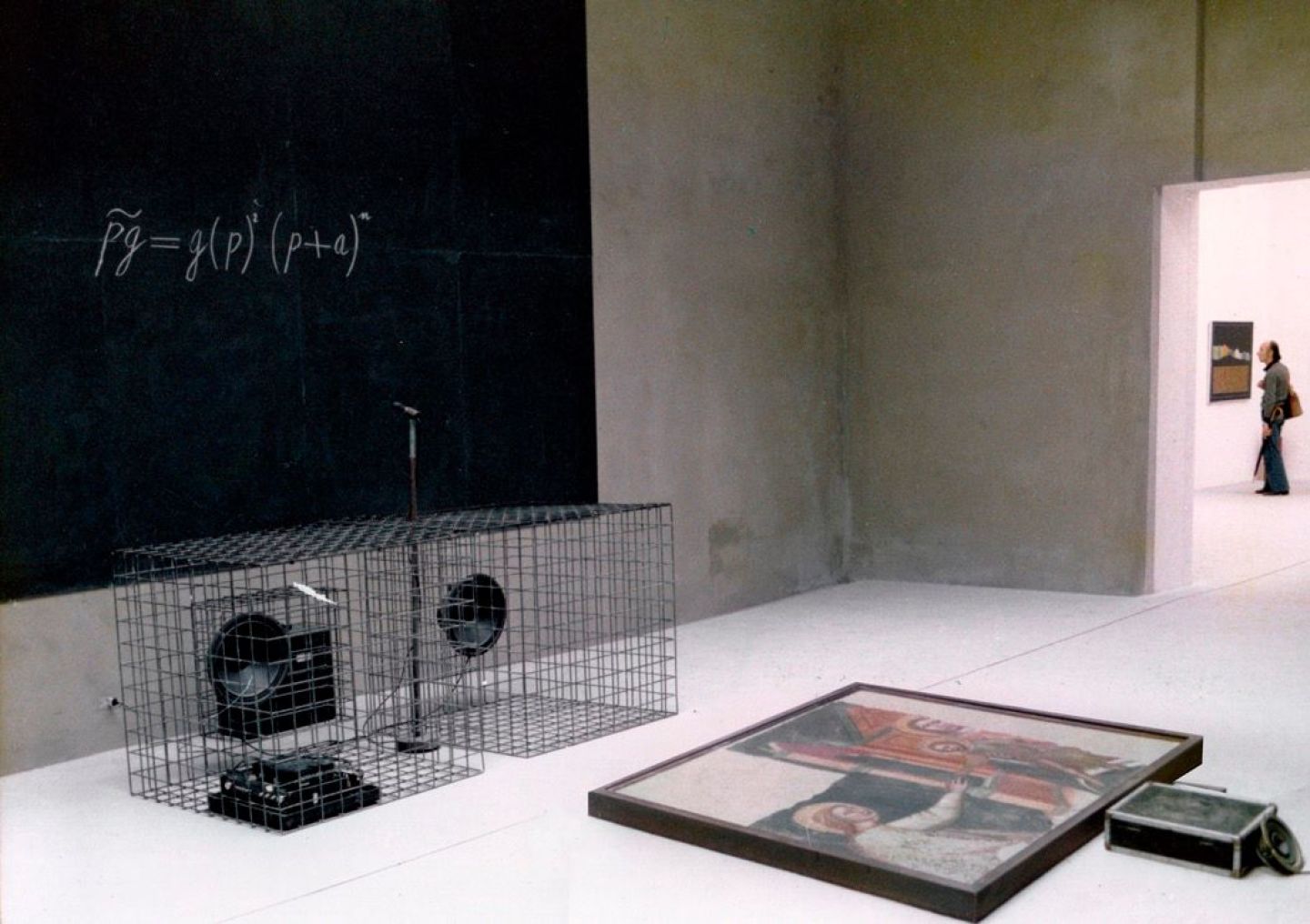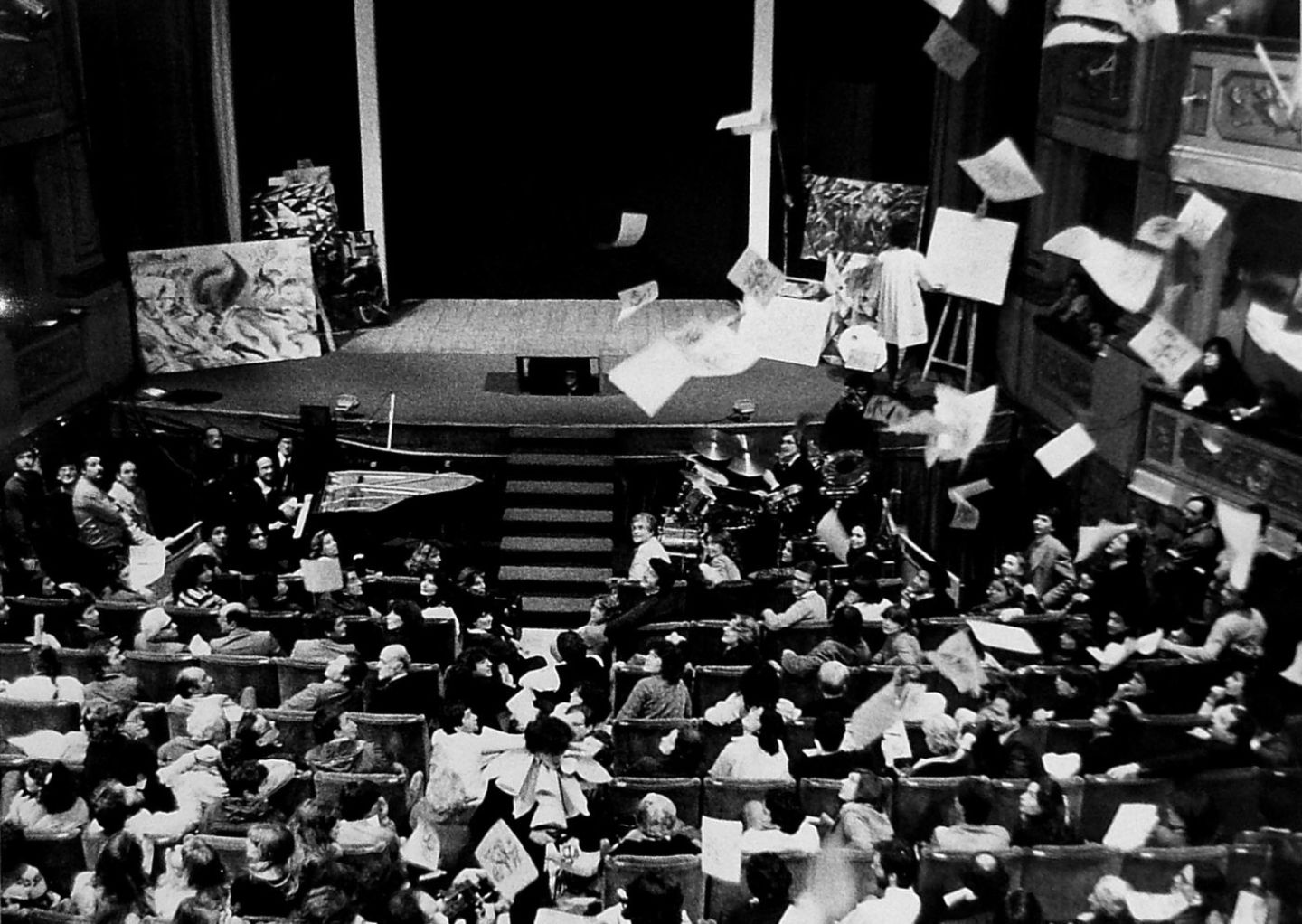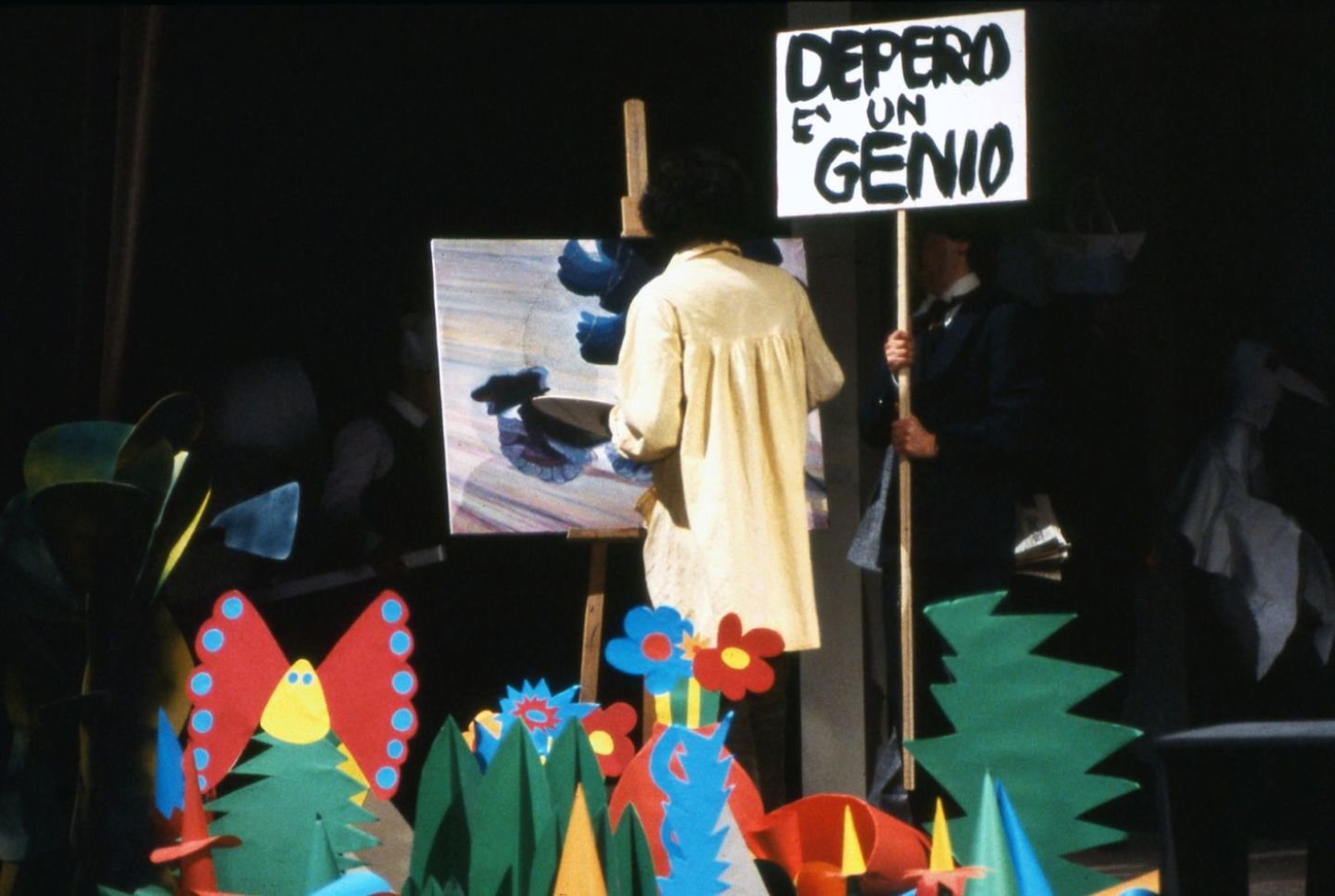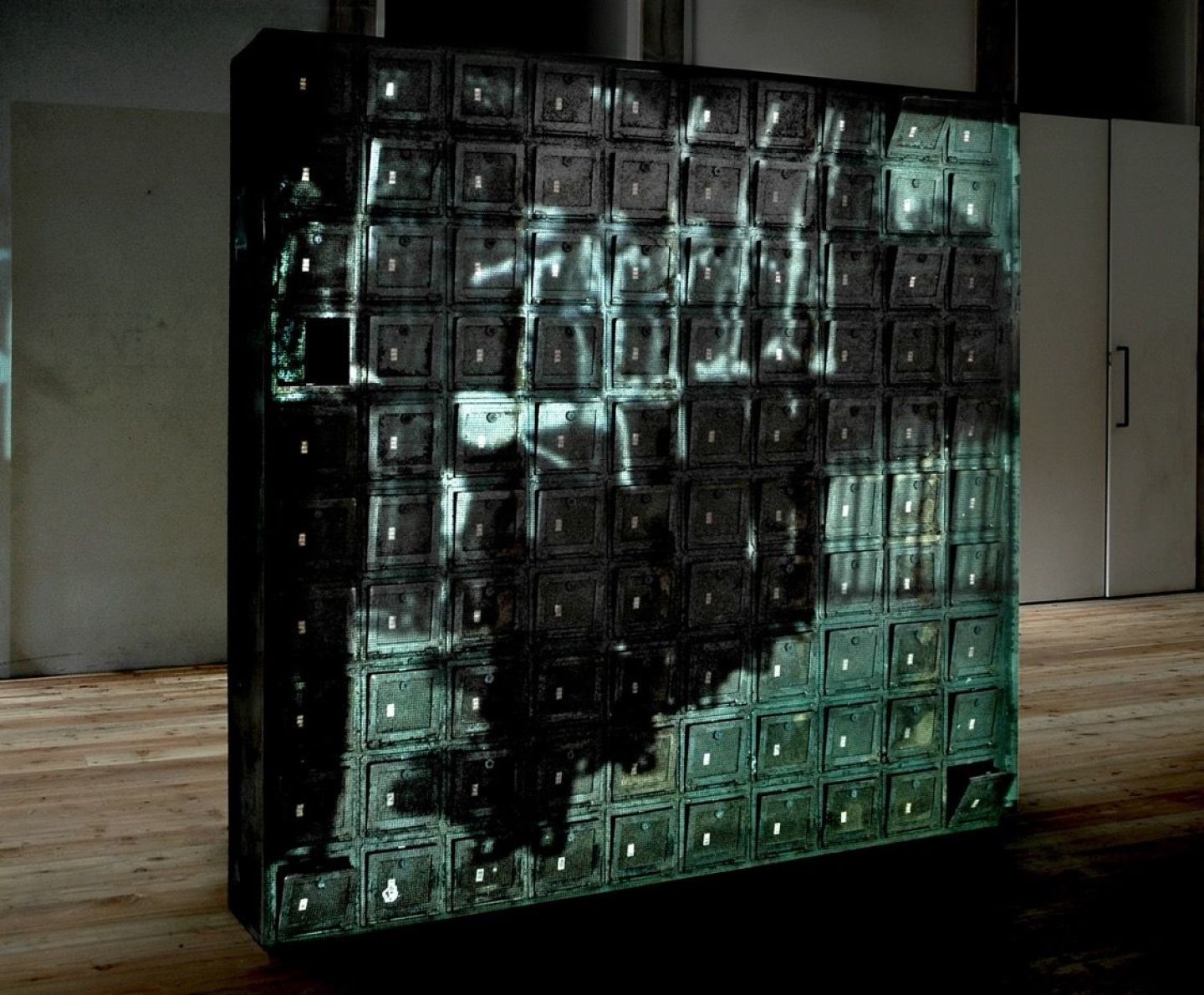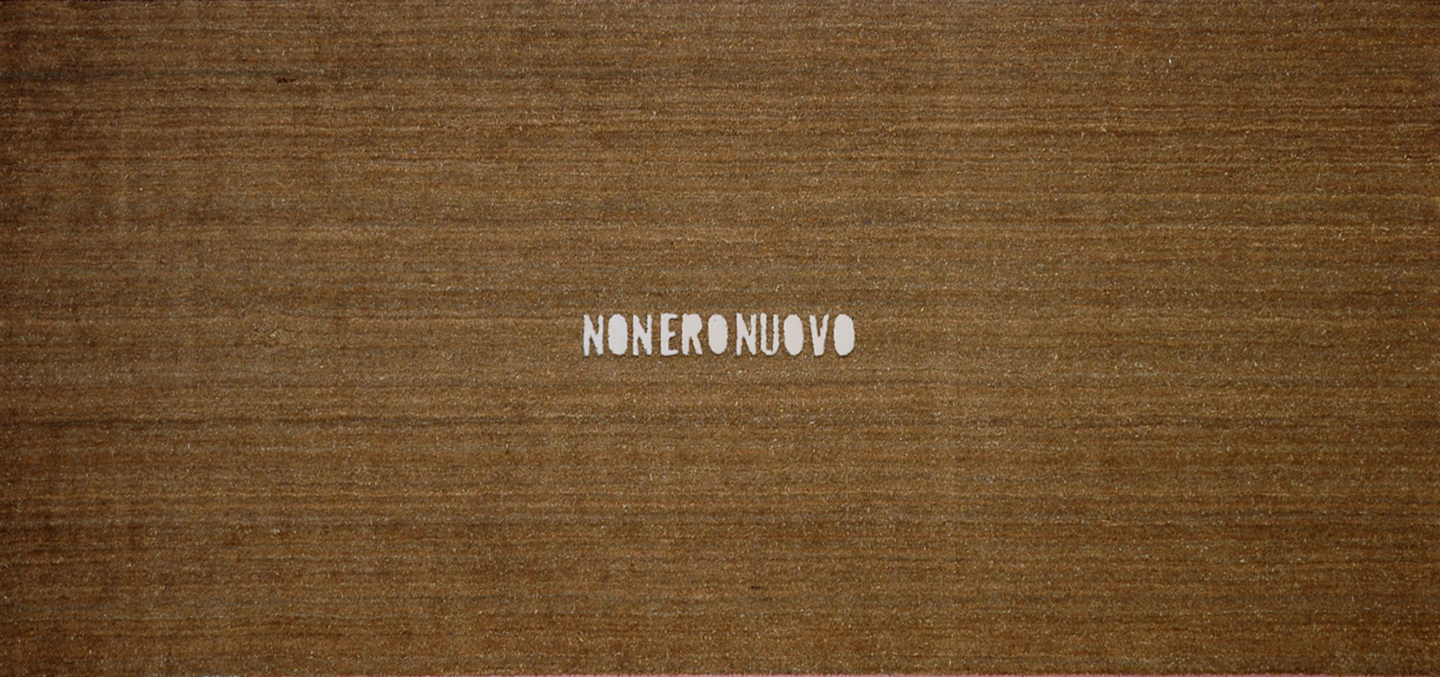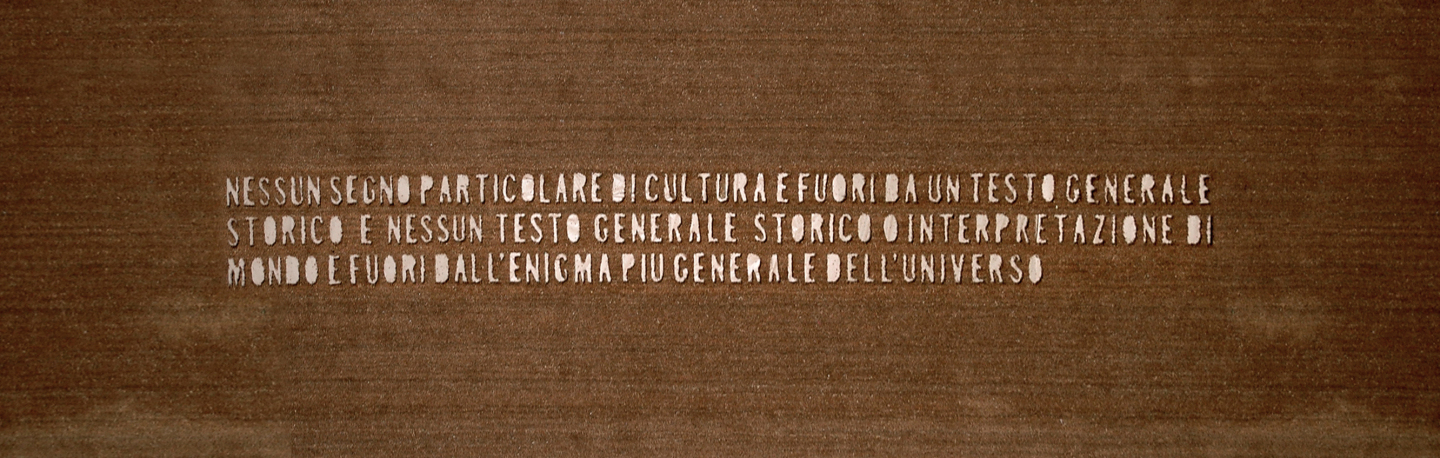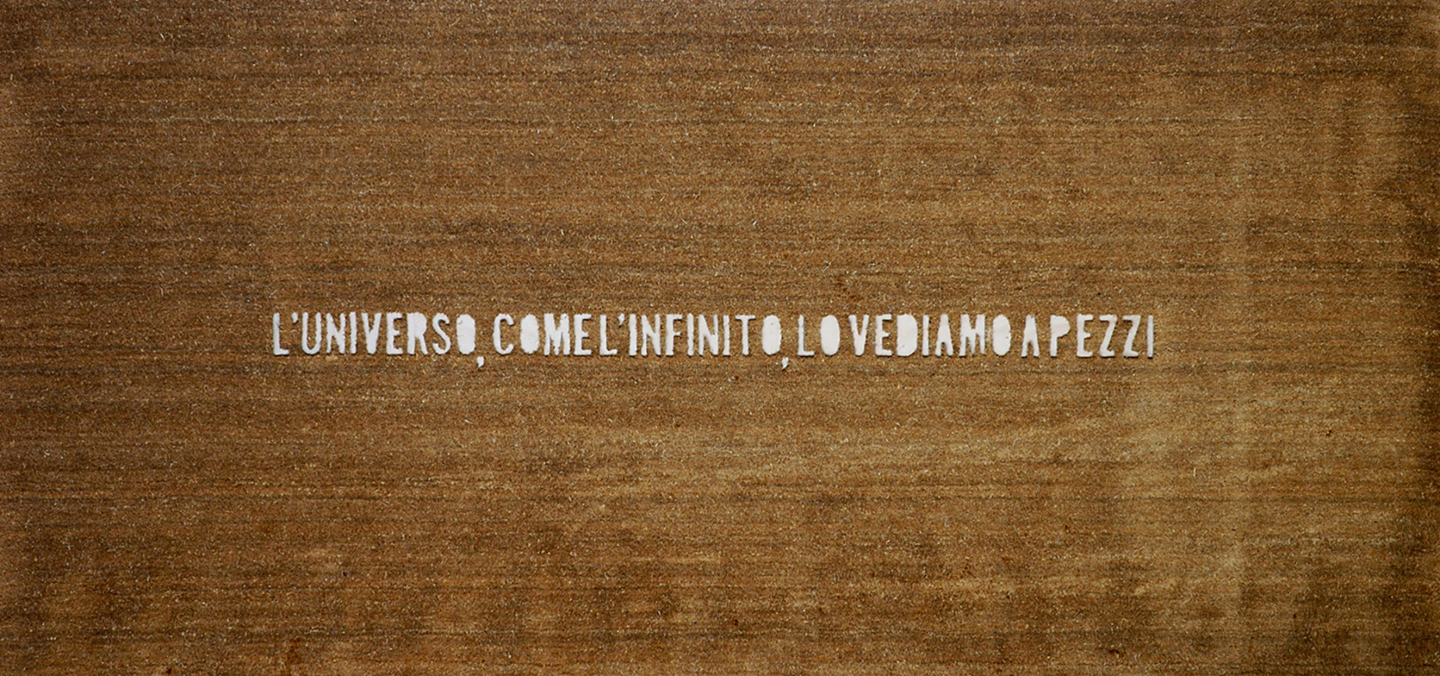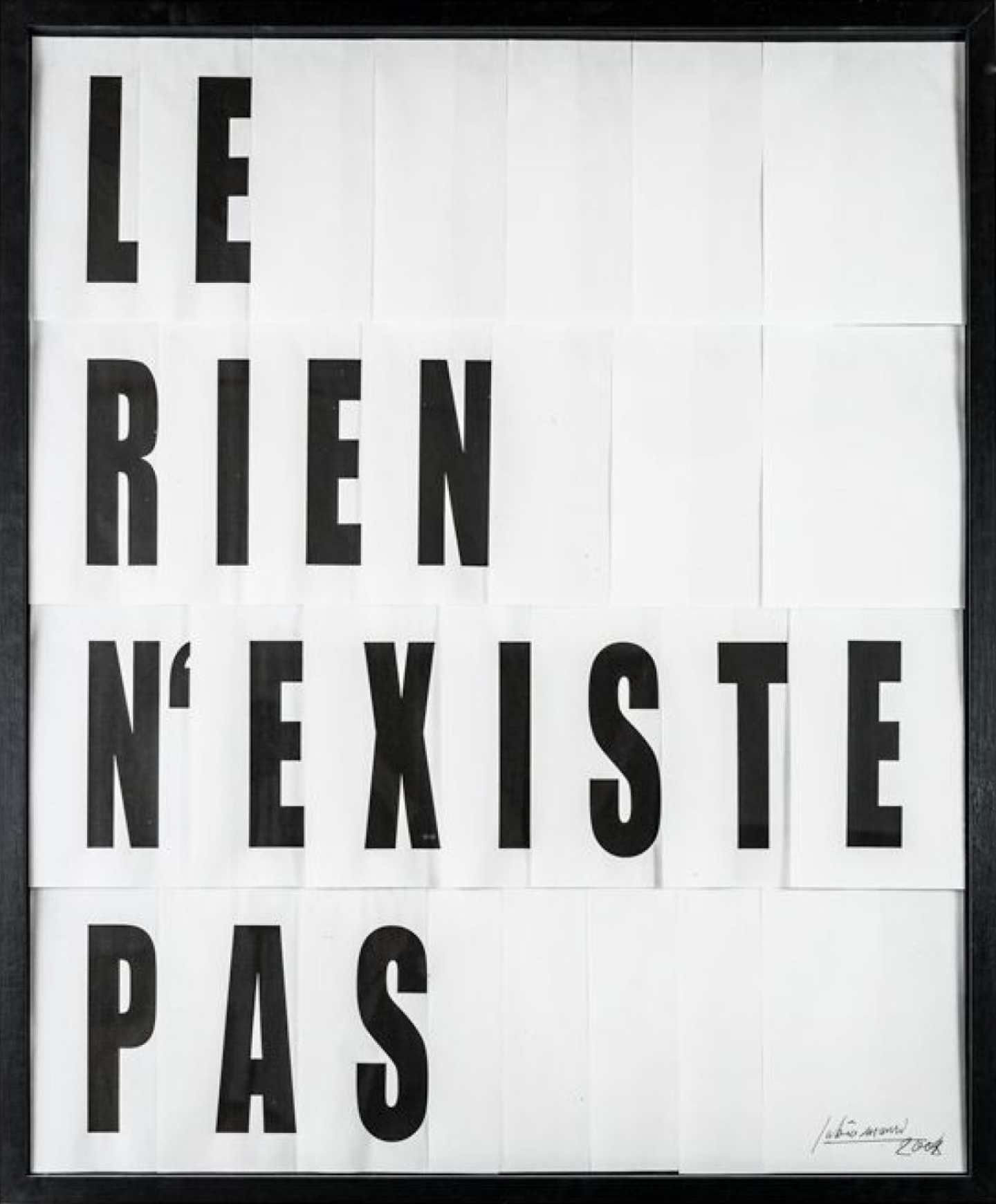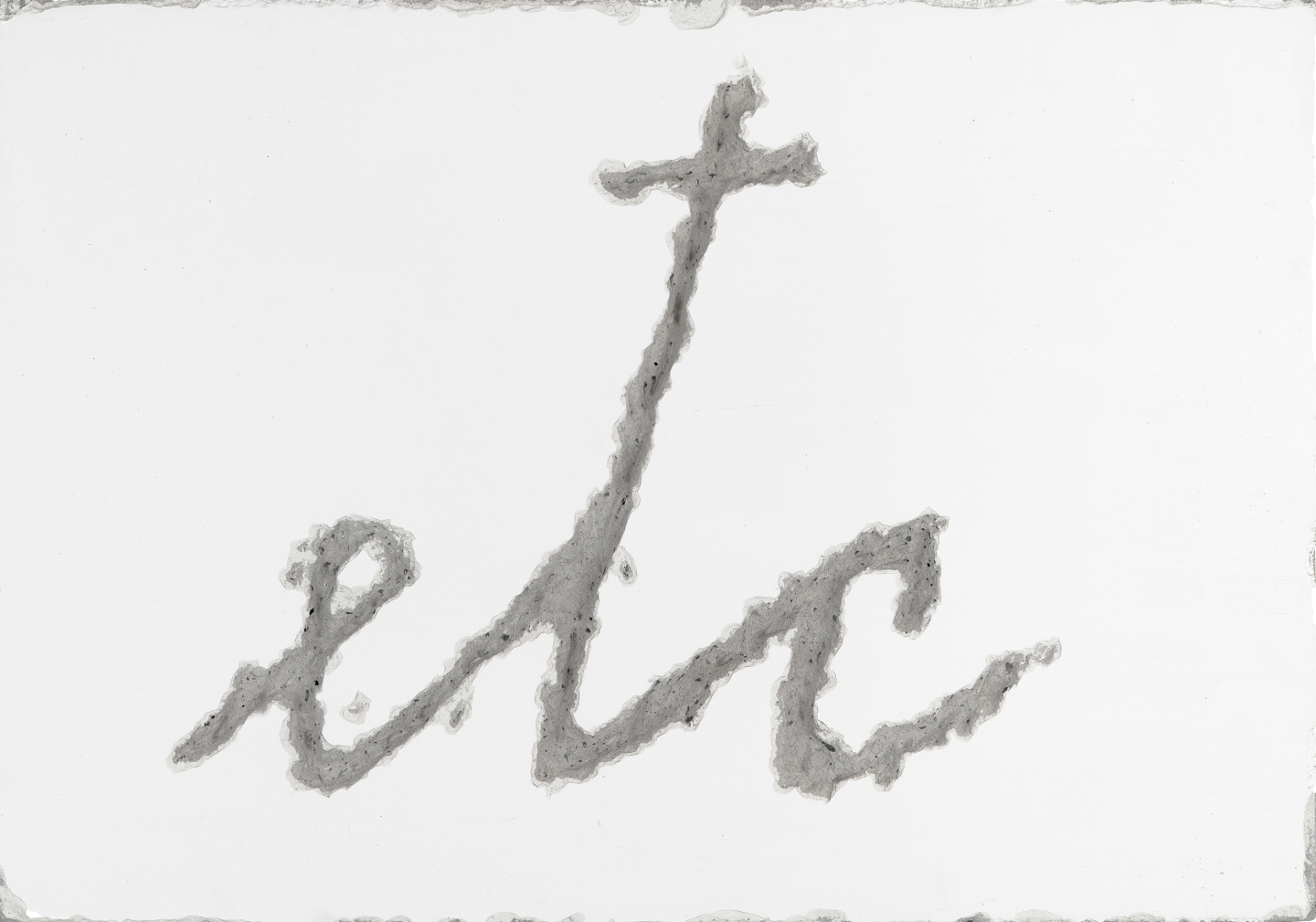Selezione opere
SCHERMO - DISEGNO VERTICALE / ORIZZONTALE, 1957
Tempera su carta
70 × 100 cm
nel Catalogo Generale
UN UOMO QUALUNQUE NEL SACCO, 1954
China su carta
27 × 20 cm
nel Catalogo Generale
SCHERMO, 1958-1959
Tela dipinta su telaio aggettante
60 × 43 × 5 cm
nel Catalogo Generale
SINATRA, 1964
Stampa su legno sagomato, tela aggettante
186 × 100 × 6 cm
nel Catalogo Generale
THE END, 1970
Smalto su tela su telaio aggettante, cornice in legno dipinto
225 × 150 × 8 cm
nel Catalogo Generale
CASSETTO, 1960
Oggetti comprati in cassetto di legno
60,4 × 74,8 × 10,2 cm
nel Catalogo Generale
CINEMA A LUCE SOLIDA, 1968
Methacrylate sculpture, electric light, 170 × 74,5 × 68 cm
Cinema a luce solida è un proiettore realizzato in plastica e neon. Una invenzione congeniale a le “Lampadine con i raggi solidificati” dei futuristi Depero e Balla.
L’artista materializza il concetto di proiezione, dando un corpo solido alla luce.
Questa convinzione parte dall’idea che tutte le componenti dell’esistenza siano reali, compreso il pensiero. La fisicità della proiezione è qualcosa che introduce plasticamente il successivo svolgimento dell’opera nella riflessione cinematica su lo Schermo e le Proiezioni. È la metafora di un sistema reale del rapporto tra mente e mondo, tra memoria delle cose e loro riconoscibilità ed evoluzione.
Fabio Mauri, Io sono un ariano, Lampi di stampa, Milano 2009, p. 62.
nel Catalogo Generale
Nel 1960 Mauri scrive la sua opera teatrale più significativa, L’Isola, commedia Pop concepita come un collage di letteratura, teatro e fumetti andata in scena in anteprima a Spoleto nel 1964 e due anni dopo a Roma.
L’ISOLA, 1964
Commedia teatrale in due tempi scritta, disegnata e diretta da Fabio Mauri
nel Catalogo Generale
LUNA, 1968
Legno, polistirolo, tela nera, scope
496 × 885 × 530 cm
nel Catalogo Generale
CHE COSA È IL FASCISMO. FESTA IN ONORE DEL GENERALE ERNST VON HUSSEL DI PASSAGGIO PER ROMA, 1971
Performance
nel Catalogo Generale
EBREA, 1971
Performance
Dora Aceto in Fabio Mauri, Io sono un ariano, Lampi di stampa, Milano 2009, p. 96.
Foto: Claudio Abate, 1971.
nel Catalogo Generale
IDEOLOGIA E NATURA, 1973, Performance
Performance
Ideologia e Natura, 1973, è una performance realizzata alla Galleria Duemila di Bologna.
Dora Aceto in Fabio Mauri,Io sono un ariano, Lampi di stampa, Milano 2009, p. 122.
Performance: Fabio Mauri (con Elisabetta Catalano).
Foto: © Elisabetta Catalano (con Fabio Mauri).
nel Catalogo Generale
IL TELEVISORE CHE PIANGE, 1972
Happening. Formato 4:3, bianco e nero, sonoro, 00:03:12
Dora Aceto in Fabio Mauri,Io sono un ariano, Lampi di stampa, Milano 2009, p. 116.
nel Catalogo Generale
VOMITARE SULLA GRECIA, 1972
Vetroresina, riso e pasta secca in sacchetti di carta telata
nel Catalogo Generale
DER POLITISCHE VENTILATOR ANNO I, N. 1, 1 NOVEMBRE, 1973
Libro illustrato in bianco e nero, rilegato con tre viti, 40 pagine 40,5 × 28 cm
nel Catalogo Generale
OSCURAMENTO, 1975
Performance
nel Catalogo Generale
Intellettuale. Il Vangelo secondo Matteo di/su Pier Paolo Pasolini, 1975
Performance con proiezione
La performance Intellettuale viene proposta in occasione dell’inaugurazione della nuova Galleria Comunale d’Arte Moderna di Bologna nel 1975 con la partecipazione di Pier Paolo Pasolini, amico fraterno di Fabio Mauri.
L’azione si svolge sulle brevi scale esterne della Galleria. All’interno del Museo si svolge la mostra, indetta da Franco Solmi, sul Movimento Dada, che Mauri stima, ma di cui non ha mai fatto parte. Mauri preferisce esibire la sua performance all’esterno del Museo. Davanti al portone sistema Pasolini su un alto sedile. Il poeta è trasformato in uno “schermo umano”. Su di lui viene proiettato il suo film Il Vangelo Secondo Matteo. L’alto volume del sonoro, eccessivo rispetto alla dimensione ridotta dell’immagine, accresce lo smarrimento esercitato dall’azione sia sul pubblico che sullo stesso Pasolini. Un fotografo, Antonio Masotti, seduto per terra tra la gente, riesce a fotografare l’azione in 15 fotografie. Immagini che hanno fatto il giro del mondo.
La scelta di proiettare il film sull’autore vuole essere, da parte di Mauri, una sorta di responsabilizzazione obiettiva dell’autore del film, costretto a sperimentare su se stesso gli effetti della sua opera. Il pubblico era formato da amici dell’infanzia e adolescenza di Mauri e Pasolini, divenuti, come i due autori, professori, editori, saggisti adulti. Pasolini non né riconobbe nessuno, preoccupato dalle loro manifestazioni di amicizia.
Dora Aceto in Fabio Mauri, Io sono un ariano, Lampi di stampa, Milano 2009, p. 160.
Foto: Antonio Masotti.
nel Catalogo Generale
SENZA IDEOLOGIA, 1975
Proiezione su latte
150 × 50 × 400 cm circa
nel Catalogo Generale
LINGUAGGIO È GUERRA, 1974
Reperti fotografici con timbro su cartoncino
nel Catalogo Generale
I NUMERI MALEFICI, 1978
Lavagna con iscrizione in gesso, stampa fotografica, gabbie in metallo, litografia incorniciata di Giorgio de Chirico, valigia, impianto audio.
Dora Aceto in Fabio Mauri, Io sono un ariano, Lampi di stampa, Milano 2009, p. 171.
Foto: © Elisabetta Catalano, 1978.
nel Catalogo Generale
UMANESIMO / DISUMANESIMO, 1980
Tela bianca, tintura rossa, fontana
nel Catalogo Generale
ENTARTETE KUNST, 1985
Olio su tela e scultura in bronzo
Entartete Kunst, 1985, installazione presentata alla Galleria Mara Coccia di Roma, affronta il rapporto tra Arte e Ideologia, centrale nel lavoro di Mauri, così centrale come nella politica del secolo XIX.
Entartete Kunst, è il nome di una mostra organizzata a Berlino, Lipsia, Düsseldorf, Salzburg dai Nazisti, per indicare le opere che quel regime considerava abominevoli.
Nell’installazione di Mauri una lunga tela riscrive la dicitura originale: ENTARTETE KUNST, Arte Degenerata. Sotto, due grandi olii su tela: uno rosso e uno giallo. Davanti ai due monocromi, simbolo di un’avanguardia moderna, c’è la scultura in bronzo di un uomo. È la sagoma, ricavata da una fotografia di Goebbels che inaugura la mostra a Berlino, nel 1938. Il viso del gerarca esprime scherno per quell’arte, per lo più espressionista, come di chi conosce la verità e la qualità.
Su una parete laterale, la A di “ENTARTETE” diventa il punto di intersezione della mostra: oltre a sottolineare per immagine la realtà di un errore ideologico, la lettera ha facoltà di farsi pittura: l’arte è capace di ribaltare e riassorbire tutto, anche la propria negazione. Sopravvive intatta alla cecità politica o ambientale che la circonda.
nel Catalogo Generale
GRAN SERATA FUTURISTA 1909-1930, 1980
Performance
Gran Serata Futurista 1909-1930, debutta al Teatro Comunale de L’Aquila con gli Allievi e i Docenti dell’Accademia di Belle Arti e la partecipazione straordinaria di Toti Scialoja, che recita Palazzeschi; Maurizio Calvesi, che, rivestito della propria maschera, interpreta la Storia Critica; la concertista vocale Joan Logue interpreta la Poesia Pentagrammata di Cangiullo, e la danzatrice Hilary Mostert balla sulle parole di un testo di Marinetti. Gli arrangiamenti musicali sono del maestro Antonello Neri che interpreta gli spartiti di Silvio Mix e di Luigi Russolo, l’aiuto regia è di Giancarlo Gentilucci. Lo spettacolo segue una struttura tripartita in modo da evidenziare i vari e molteplici linguaggi e le invenzioni futuriste dall’anteguerra (interventismo), in guerra 1915-18 (esperienza al fronte), fino al dopoguerra (delusione e dispersione dei futuristi). Consapevole delle innovazioni dell’avanguardia storica, Mauri compie una valutazione analitica del Futurismo, attuando una sorta di ricostruzione filologica originale sui testi del Teatro Parolibero e delle Poesie Parolibere, della Poesia Pentagrammata, e gli spartiti di Luigi Russolo e di Silvio Mix. Per la Cinematografia futurista , rara e quasi del tutto perduta, Mauri proietta un suo ritrovamento presso l’Istituto Luce di Roma, un nastro di pochi minuti, dove la firma è cancellata; probabilmente di Settimelli e Corra. Nella proiezione si vede l’animazione di un disegno astratto, sembra di Balla ma è molto simile a uno dei primi disegni di Corra. La banda, a volte in platea, altre sul palcoscenico, ha una funzione evocativa di avvenimenti cruciali: lo scoppio della guerra, il funerale futurista, la vittoria finale. I personaggi sono più di 50. Lo spettacolo dura 4 ore.
Dora Aceto in Fabio Mauri, Io sono un ariano, Lampi di stampa, Milano 2009, p. 224.
Foto: © Marcello Norberth, 1980; © Maria Mulas, 1982; © Elisabetta Catalano, 1980.
nel Catalogo Generale
CHE COSA È LA FILOSOFIA. HEIDEGGER E LA QUESTIONE TEDESCA. CONCERTO DA TAVOLO, 1989
Performance
Dora Aceto in Fabio Mauri, Io sono un ariano, Lampi di stampa, Milano 2009, p. 268.
Foto: Claudio Abate, 2012.
nel Catalogo Generale
IL MURO OCCIDENTALE O DEL PIANTO, 1993
Valigie, borse, casse, involucri in cuoio, tela, cartone, legno, metallo, dischi, borraccia, manici di ombrello, stampe su carta, pianta di edera in vaso
400 × 400 × 60 cm
L'opera contiene una fotografia di © Elisabetta Catalano relativa alla performance Ebrea, 1971 di Fabio Mauri.
Foto: Graziano Arici, 1993.
Video: Dario Bellini, 2020.
nel Catalogo Generale
MACCHINA PER FORARE ACQUERELLI, 1990
Pantografo da scultore in ferro e legno, acquerello su carta, monete
370 × 160 × 290 cm
nel Catalogo Generale
REBIBBIA, 2006
Proiezione digitale su mobile in ferro
197,5 × 190 × 30 cm
Dora Aceto in Fabio Mauri,Io sono un ariano, Lampi di stampa, Milano 2009, p. 452.
Foto: Sandro Mele.
nel Catalogo Generale
NON ERO NUOVO, 2009
Taglio su zerbino
201 × 420 × 1,8 cm
nel Catalogo Generale
LE RIEN N’EXISTE PAS, 2008
Stampa digitale su carta, collage su tavola
125 × 103 cm
nel Catalogo Generale
ETC, 2009
Incisione su cemento intonacato
68 × 98 × 9 cm
nel Catalogo Generale

VUOI SAPERNE DI PIÙ, VEDERNE DI PIÙ O FARE RICERCA? ACCEDI AL CATALOGO GENERALE A CURA DI CAROLYN CHRISTOV-BAKARGIEV
Catalogo Generale Catalogo Generale